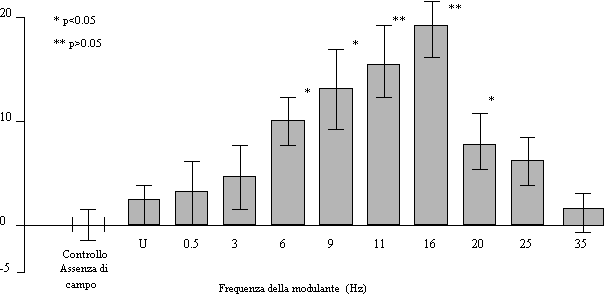
Effetti non termici dell'esposizione ad un campo elettromagnetico alle ELF
Gli studi risalgono agli anni compresi tra il 1975 ed il 1988 e si tratta delle ricerche di Bawin, di Blackman e di Bayley; queste analisi si riferiscono ad un livello inferiore della scala biologica, infatti considerano il flusso di calcio dal cervello di embrioni di pulcini in caso di esposizione ad un campo alle ELF.
1. Studi sul flusso del calcio radioattivo da encefali di embrioni di pulcini esposti a campi alla ELF
Negli anni intorno al 1975 nell'ambito degli studi sull'effetto uditivo delle microonde sono stati condotti degli esperimenti nei quali si studiava l'azione proprio delle microonde sul cervello di pulcini, ed in particolare sul flusso del calcio.
Negli esperimenti si utilizzava un segnale a frequenza di 147 MHz modulato in ampiezza con un segnale di frequenza compresa fra 0.5 e 35 Hz.
Quello che si notava (Fig.1) era un effetto significativo intorno alla modulante a 16 Hz.
L'effetto era certamente di tipo non termico in quanto l'energia associata al segnale modulato era sempre la stessa, dato che variava solo la frequenza della modulante e non l'ampiezza, mentre gli effetti si avevano solo in corrispondenza a determinate frequenze della portante.
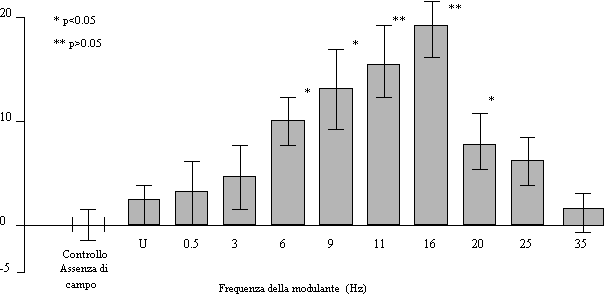
Fig.1 Effetti di un segnale a 147 MHz modulato in ampiezza sul flusso del 45Ca++ dal cervello di embrioni di pulcini
Notando che gli effetti erano legati alla frequenza della modulante, che in questo caso era alle ELF, si è focalizzata l'attenzione proprio sui segnali alle ELF.
Un esperimento, condotto da Blackman fra gli altri, consisteva nella rimozione del cervello in pulcini di età compresa fra 1 e 7 giorni. I due emisferi dell'encefalo venivano separati e ciascuno dei due veniva posto in una soluzione salina fisiologica contenente calcio radioattivo e incubato per mezz'ora alla temperatura di 37 C. Poichè il bagno in cui erano immersi i due emisferi era costituito da una soluzione salina, il cervello continuava ad essere attivo per un certo tempo e quindi il calcio radioattivo penetrava all'interno. Quindi il cervello veniva estratto dalla soluzione e lavato per rimuovere tutto il calcio e le eventuali altre sostanze ancora presenti esternamente. A questo punto ciascuno dei due emisferi veniva posto in una soluzione identica alla prima, ma priva di calcio radioattivo, ma mentre uno era in seguito sottoposto per 20 minuti a campi magnetici ed elettrici in particolari condizioni di frequenza e di intensità, l'altro era sottoposto ad una esposizione simulata. L'esposizione simulata e' detta anche prova sham e consiste in una non esposizione al campo elettromagnetico nelle stesse condizioni ambientali; il fatto che tali condizioni non varino permette di verificare se sia il campo o meno a creare fenomeni di flusso variabile. Al termine dei 20 minuti di esposizione, la soluzione era rappresentativa della quantità di calcio radioattivo proveniente dal tessuto. Ogni volta venivano presi 4 campioni e sottoposti all'esposizione o alla esposizione simulata. Il procedimento veniva ripetuto alternando l'esposizione alla simulazione, in modo che generalmente in un test si avevano da 6 ad 8 set di coppie exposed / sham. Per valutare i risultati dell'esposizione venivano utilizzate opportune analisi statistiche.
Il sistema di esposizione usato in questi esperimenti era una cella di Crawford (Fig.2 ), o cella TEM, chiusa su un carico da 50 .
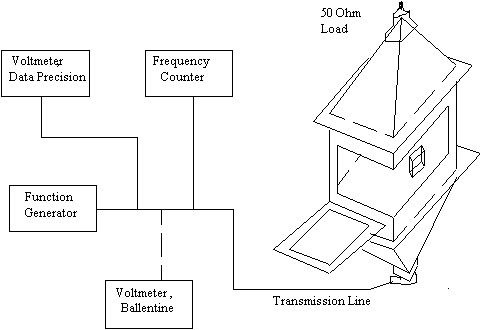
Fig.2 Cella TEM
La cella è costituita da una scatola metallica con l'esterno a massa; al centro della scatola c'è un piatto metallico, determinato dall'allargamento del conduttore centrale del cavo coassiale, isolato dalle pareti della cella, alimentato per produrre un campo elettrico ed un campo magnetico nello spazio tra il piatto stesso e le pareti esterne [Blackman, 1982]. I campioni di tessuto cerebrale nel test erano di forma tubolare e venivano posti al centro della camera. La cella di esposizione era mantenuta alla temperatura di 37 C durante tutto l'esperimento.
Lo scopo di esperimenti di questo tipo era verificare se un campo elettromagnetico
potesse agire sul flusso di calcio fra interno ed esterno delle cellule
del cervello.
Quando il cervello veniva espiantato era ormai elettricamente morto: entro
un minuto e mezzo (90 sec) dalla rimozione, da esso non si riceveva alcun
segnale elettrico e, se sottoposto a shock elettrico, non dava nessuna
risposta caratteristica di un tessuto elettricamente attivo (Dr. William
Howell).
Blackman, in questo contesto, ha portato avanti numerosi esperimenti, durante i quali ha dimostrato che gli effetti rilevati non erano dovuti ad alterazioni della struttura cerebrale come conseguenza dell'espianto. Per verificare questo, Blackman ha testato l'efficienza del cervello in termini di riduzione dell'apporto di ossigeno, ossia ha sottoposto a test la capacità del cervello di utilizzare l'ossigeno, fino a 60 minuti dopo l'espianto; al termine del trattamento il tessuto cerebrale era ancora in grado di metabolizzare abbastanza bene l'ossigeno. La curva che descrive l'andamento della concentrazione di O2 al variare del tempo è riportata in Fig.3; si vede che durante l'esperimento si ha una riduzione dell'apporto di ossigeno ma, mantenendo in condizioni idonee il tessuto, questo è in grado di conservare inalterato il suo metabolismo. Il minuto zero corrisponde all'istante in cui il cervello viene posto nella cella con l'elettrodo applicato..
.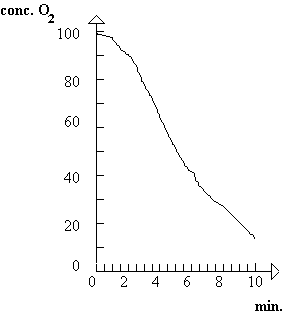
Fig. 3
Il primo risultato evidenziato negli esperimenti sul flusso del calcio radioattivo dal cervello è stato quello chiamato "effetto finestra". Blackman ha osservato comportamenti anomali del tessuto a 16 Hz e non a frequenze inferiori o superiori. Questo poteva spiegare il motivo della incongruenza dei risultati ottenuti dai due gruppi di ricercatori, in quanto per avere assenza di effetto era sufficiente cambiare la frequenza del campo. Blackman ha inoltre riscontrato situazioni di effetto finestra anche nel dominio dell'ampiezza del campo, ossia fissata una certa frequenza e variando l'intensità del campo applicato si notavano degli effetti solo in corrispondenza ad alcuni valori dell'ampiezza.
I risultati sperimentali significativi sono riportati in Fig.4. La significativita' di una differenza di medie si puo' fare con il T-TEST di STUDENT che la misura con un valore di probabilita' "p". Tale valore numerico viene associato alle differenze osservate: ad un valore di "p" piccolo , dell'ordine di 0.01~0.05, equivale una differenza statisticamente molto significativa:
Si nota l'effetto finestra a 16 Hz. Si sono classificati come significativi i dati che presentano valori del parametro probabilistico "p" minori di 0.05 .
ESPERIMENTI DI BLACKMAN (1982-88)
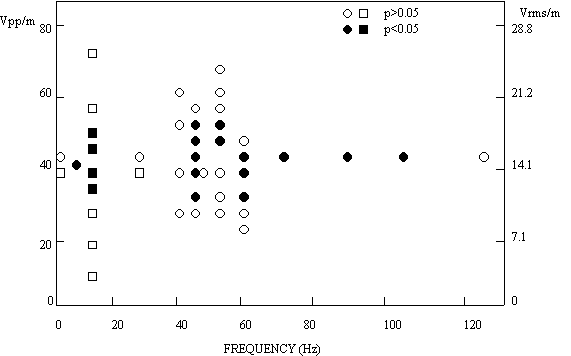
Fig.4 Efflusso di ioni calcio dal cervello di embrioni di pulcini esposti a campi ELF
Nell'esperimento di Blackman ogni quadratino equivaleva a diverse prove effettuate in certe condizioni: la prova era considerata significativa quando i valori medi dei campioni estratti presentavano un valore di p dell'ordine di 0.05 ed un comportamento diverso dai campioni sham.
Blackman successivamente ha esteso i suoi esperimenti fino a frequenza di 550 Hz ed i risultati ottenuti sono stati classificati nella Fig.5: in ascissa si trova la frequenza, in ordinata si trovano i valori di probabilità. Si individuano tre fasce, di cui la più bassa è quella di maggiore significatività.
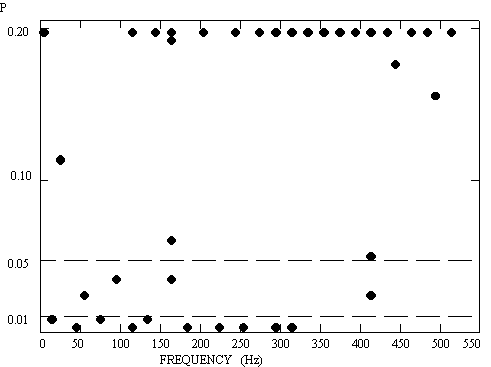
Fig. 5 Dipendenza dalla frequenza del rilascio di ioni calcio rappresentata come valori del parametro probabilistico "p"
Il problema degli effetti finestra era rilevante: anche ripetendo lo stesso esperimento in laboratori diversi si trovavano risultati differenti. Blackman in questo contesto ha avuto l'intuizione di aggiungere una variabile al sistema: la densità del campo geomagnetico locale misurata nel laboratorio in cui si lavorava. Quindi i dati più significativi sono stati posti in relazione al campo geomagnetico locale e sono stati ottenuti due risultati rilevanti (Fig.6):
- normalizzando il campo geomagnetico gli effetti si notavano a frequenze di 15 e 45 Hz;
- raddoppiando il campo statico si è riscontrato un effetto a 30 Hz.
I dati significativi si presentavano in corrispondenza a valori di campo multipli del campo geomagnetico e questo spiegava ancora la differenza dei risultati ottenuti a frequenze diverse dai vari gruppi di ricerca.
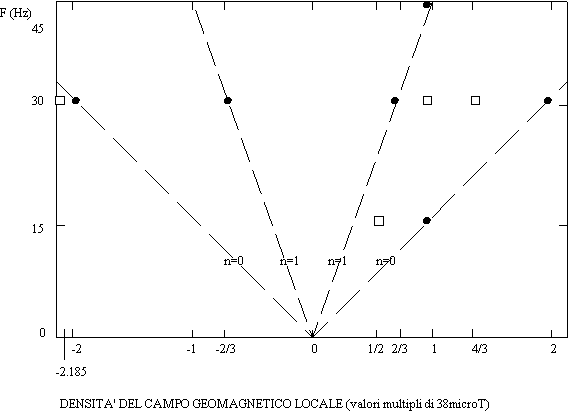
Fig. 6 Influenza del campo geomagnetico locale sul rilascio di ioni calcio
Il grafico vuole dare una relazione matematica: l'effetto è proporzionale ad un campo statico B0
![]()
dove 0 è la frequenza alla quale si ha l'effetto ed n una costante.
Si ha per n=0
![]()
con A costante. A si può calcolare come
![]()
Sostituendo questa espressione nella relazione che definisce 0 si ottiene
![]()
Si riconosce che questa è la formula della risonanza del ciclotrone.
Osservando il grafico si vede che a 15 Hz con un campo di 38 T si ha un effetto significativo, se raddoppia l'intensità del campo geomagnetico, anche la frequenza alla quale si ha l'effetto raddoppia.
Il grafico è stato ottenuto da osservazioni di carattere puramente empirico e dietro non c'è alcuna teoria.
Un secondo tipo di esperimenti è stato condotto da Smith e da Liboff sulle alghe diatomee. Queste alghe hanno la caratteristica di muoversi a seconda della quantità di calcio che entra nella loro struttura cellulare.
Liboff ha effettuato i suoi studi al variare della concentrazione di calcio nel bagno in cui erano contenute le alghe ed al variare della frequenza del campo elettromagnetico a cui le stesse erano esposte.
I risultati relativi al comportamento in frequenza sono riportati in Fig.7, mentre quelli ottenuti al variare della concentrazione del calcio sono rappresentati in Fig.8.
Analizzando la Fig.7 si può osservare che si tratta di una campana di risonanza centrata all'incirca a 16 Hz, relativa ad un campo in alternata di ampiezza pari a 0.209 T.
Sull'asse delle ordinate è presente la mobilità dell'alga, definita come la percentuale di alghe che hanno subito uno spostamento maggiore di 1.10-6 m. A ciascun punto del grafico è associato un valore che rappresenta il numero di diatomee trattate a ciascuna frequenza.
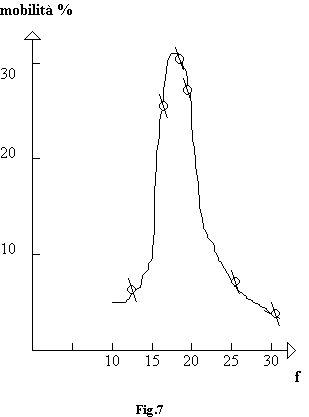
In figura 8 sono presenti due spezzate :
- la spezzata relativa ai cerchietti vuoti è quella ottenuta in assenza di campo;
- la spezzata relativa ai cerchietti pieni si riferisce all'esperienza in presenza di campo a frequenza di 16 Hz, ampiezza in continua (B0) ed in alternata (Bac) pari a 20.9.10-6 T.
Gli effetti significativi si manifestano in prossimità delle concentrazioni 0.1, 0.25, 0.5 mM; per valori più bassi l'effetto del calcio è trascurabile, mentre per valori più alti si ha un fenomeno di saturazione, per cui aumentando la concentrazione del calcio si sente poco la presenza del campo elettromagnetico.
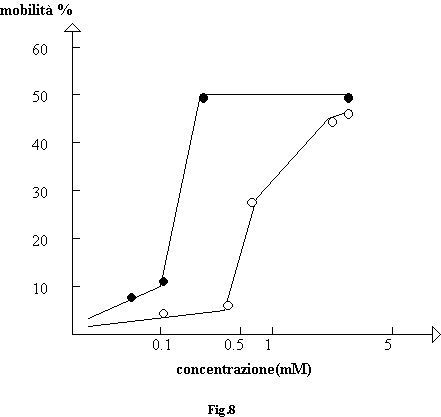
Una terza serie di esperimenti è stata condotta da Thomas sui ratti. Questi venivano esposti per 30 minuti a due campi magnetici: un campo magnetico orizzontale variabile, di frequenza pari a 60 Hz ed uno verticale (B0) orientato in modo opposto al campo magnetico terrestre, in modo da ridurne il valore.
Dopo l'esposizione i ratti venivano posti in dei box, dove si effettuavano test comportamentali sull'alimentazione e sullo stress. Il sistema di esposizione comprende, oltre alla cella di esposizione, un generatore di segnale in continua ed uno in alternata. La tab.1 mostra le diverse condizioni di esposizione con i relativi comportamenti osservati:
- nel primo caso sono stati osservati animali in condizioni di vita normale e sono stati registrati i loro comportamenti, classificandoli come reazioni naturali (o base, baseline);
- nel secondo caso gli animali sono stati posti nella cella TEM, ma senza applicare il campo variabile, per provare se eventuali variazioni comportamentali fossero dovute al cambiamento ambientale e non ad effetti elettromagnetici (ad esempio, il ratto poteva avere paura);
- nel terzo caso i ratti sono stati esposti sia al campo statico di 0.404 G che ad un campo variabile a frequenza di 60 Hz;
- nel quarto caso si è studiato il comportamento degli animali esposti a campo statico di intensità pari a 0.216 G e in assenza di campo variabile;
- nel quinto caso i ratti sono stati esposti a campo statico di ampiezza di 0.216 G e a campo variabile a frequenza di 60 Hz.
I test comportamentali prevedevano l'osservazione dei tempi di reazione degli animali, in particolare i tempi di richiesta di cibo, e dello stress presentato dai ratti.
I comportamenti rilevati sono stati concordanti con la situazione "baseline" nei casi secondo, terzo, quarto mentre nel quinto si è avuta un'alterazione.
|
Esperimento |
Statico |
Frequenza |
Test FR |
Test DRL |
|
Normale |
nessuna esposizione |
nessuna esposizione |
Baseline |
Baseline |
|
Sham |
0.404 |
..... |
Baseline |
Baseline |
|
C.M. Oscillante |
0.404 |
60 |
Baseline |
Baseline |
|
Nessun campo Geomagnetico |
0.261 |
..... |
Baseline |
Baseline |
|
Risonanza Ciclotrone |
0.261 |
60 |
Baseline |
Cambio |
2.Effetti in vivo dell'esposizione a campi alle ELF
Negli anni '60 hanno avuto inizio in Russia gli studi sugli eventuali effetti in vivo dell'esposizione a campi elettromagnetici alle ELF.
Dalle prime osservazioni sperimentali si notò come le principali conseguenze dell'esposizione a tali campi fossero emicranie, torpore e senso di affaticamento.
Si tentò allora di comprendere su quale meccanismo biologico tali campi andassero ad agire e si dimostrò come essi influenzassero in maniera evidente la secrezione di melatonina. La melatonina è un ormone che ha la funzione di favorire il rilassamento, viene infatti secreto principalmente di notte; una sua diminuzione può, quindi, portare a situazioni di stress, le quali, da studi recenti, sembrano risultare legate all'insorgere di tumori.
Consideriamo ora alcuni degli studi sugli effetti in vivo dell'esposizione a campi alle ELF.
Wever nel 1968 osservò che come conseguenza dell’'esposizione ad un campo a 50 Hz si aveva un arresto del prolungamento del ciclo circadiano ( dal latino "circa un giorno" e' un ritmo o attivita' animale o vegetale che si ripete ogni 24 ore -es:bioritmo sonno veglia-) nell'uomo, che generalmente si presenta in assenza di riferimenti temporali; in seguito Ehret e Groh ipotizzarono che la disincronizzazione del ciclo circadiano fosse l’'effetto più importante dovuto all’esposizione alle ELF e iniziarono quindi una serie di studi atti ad approfondire tale aspetto.
Il primo punto che venne evidenziato fu che sia il campo elettrico che quello magnetico possono alterare le funzioni della ghiandola pineale: la ghiandola pineale o epifisi e' una piccola ghiandola ovoidale, situata internamente alla testa, che secerne un ormone (melatonina) che interviene nello sviluppo degli organi genitali; e' infatti particolarmente attiva nei primi sette anni di vita, nei quali svolge una funzione inibente delle gonadi, e subisce un involuzione fisiologica verso la puberta'; la sua distruzione, per causa di tumori, prima della puberta' determina la comparsa di una precoce maturita' sessuale. In seguito a degli esperimenti si arrivo' ad intuire che ci fosse una connessione tra epifisi e la luce; per chiarire questa connessione si misuro' l'attivita' di un enzima epifisario che presiede ad una delle tre reazioni chimiche che portano dal 5-idrossitriptofano (un aminoacido) alla melatonina. I ricercatori posero alcuni ratti in un ambiente ad illuminazione regolata:12 ore di luce e 12 ore di oscurita'. Venne cosi' confermato che la luce esercita un'azione frenante sull'epifisi. Si stabili' cosi' l'esistenza di un ritmo circadiano: esistono altri ritmi circadiani nel nostro organismo ma quello epifisario e' l'unico regolato esclusivamente da stimolazioni dell'ambiente esterno. La luce blocca la funzionalita' dell'epifisi, questa secerne poca melatonina e l'attivita delle ghiandole sessuali aumenta; l'oposto avviene durante i periodi di oscurita'. Il cammino di tale processo e' questo: la luce stimola le cellule sensoriali della retina, queste trasformano l'impulso luminoso in impulso nevoso che, attraverso il nervo ottico e il ganglio cervicale superiore, raggiunge le cellule epifisarie tramite il contatto diretto che queste stabiliscono con le fibre nervose. All'impulso nervoso queste rispondono con una diminuzione della sercrezione della melatonina. L'epifisi e' uno dei trasduttori del nostro corpo trasformando uno stimolo nervoso in uno stimolo endocrino.
Welker nel 1983 mostrò che campi magnetici artificiali possono inibire l’attività NAT (nacetiltrasferase: l'enzima atto alla produzione di melatonina) nell’epifisi dei topi; Semm, nello stesso anno, eseguì degli studi sia in vivo che in vitro che confermarono che campi magnetici di bassa intensità possono alterare le funzioni dell’epifisi .
Tutti questi studi sono stati condotti con campi statici di bassa intensità; i dati di laboratorio sugli effetti sui ratti dovuti a campi magnetici in alternata di maggiore intensità devono ancora essere raccolti e valutati.
Wilson nei primi anni '80 condusse una serie di studi sull’esposizione cronica (21 giorni) a campi elettrici alle ELF di topi di 55 giorni di età, variando l'ampiezza dei campi, ed ottenendo dei risultati significativi, sintetizzati anche in Fig.1:
- l’esposizione a campi elettrici di intensità compresa tra i 2 e i 40 kV/m può eliminare il normale picco notturno di secrezione di melatonina pineale;
- il picco notturno di melatonina risulta ritardato di 1.4 ore e diminuisce in topi esposti dal momento del concepimento fino a 23 giorni dopo la nascita a un campo di ampiezza di 10 o 65 oppure 130 kV/m;
- l'ampiezza dei campi alle ELF che provocano la scomparsa del picco notturno nella produzione di melatonina presenta un valore di soglia tra gli 0.2 e i 2 kV/m (a valori prossimi a 2 kV/m non si notano effetti dovuti all’esposizione alle ELF);
- nei topi esposti, il normale ritmo della melatonina si ristabilisce dopo tre giorni dalla cessazione dell’esposizione ad un campo alle ELF di 39 kV/m (Fig.1).
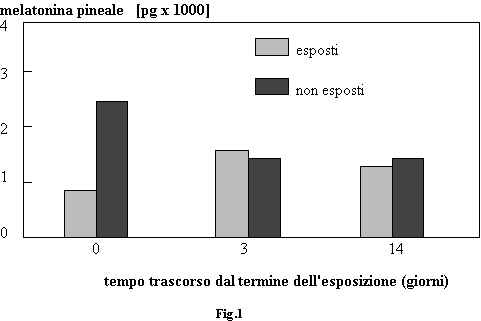
La Fig. 2 mostra un raffronto tra la concentrazione di melatonina misurata in animali esposti ad un campo alle ELF per un periodo di tempo compreso tra il concepimento e lo svezzamento (23 giorni), e in animali sottoposti ad esposizione simulata. La misura della concentrazione dell'ormone viene fatta in varie fasi del ciclo circadiano.
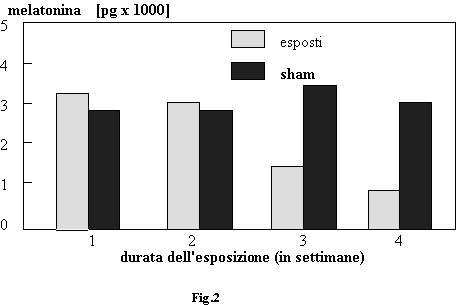
In seguito a queste osservazioni sono iniziati degli studi per determinare i cambiamenti nel metabolismo pineale associati alla riduzione di melatonina negli animali esposti a campi alle ELF a 55 giorni di età. I risultati ottenuti sono stati i seguenti:
- l’attività del NAT diminuisce dopo circa tre settimane di esposizione;
- scompare il ritmo giorno-notte nella serotonina e questo fa sì che i livelli notturni della serotonina pineale siano più alti del normale;
- a causa della diminuzione dell'attività NAT, diminuisce anche il livello del suo metabolita immediato, la serotonina N-acetil, ma si nota un aumento compensatore nel 5-metoxitripolo.
Tutte queste osservazioni sono riconducibili all'alterazione biochimica nella sintesi del NAT; l’effetto, comunque, non è stato studiato abbastanza per dare indicazioni su eventuali cambiamenti nella funzione neuronale.
L’andamento dell’attività NAT è visualizzato in Fig.3:
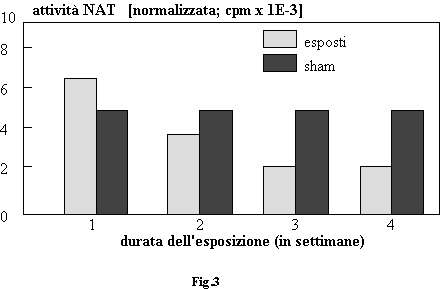
E' stato finora dimostrato che esiste una relazione tra i meccanismi di sintesi e di rilascio della melatonina e l'esposizione a campi alle ELF. Considerando l'organismo umano nel suo complesso si vede che esistono un certo numero di meccanismi possibili che possono rilevare la risposta della funzione pineale ai campi alle ELF.
Si è visto come i campi agiscano sull'attività NAT; misure più precise hanno mostrato che nei soggetti esposti alle radiazioni è alterato o addirittura assente l'ingresso neuronale richiesto per la stimolazione dell'attività NAT ( -adrenergic).
E' anche possibile che l'alterazione del funzionamento dell'epifisi osservata nei topi, così come negli esseri umani, sia una manifestazione di stress. Vediamo i risultati delle osservazioni fatte in questa direzione:
- gli animali esposti ad un campo di circa 39 kV/m mostrano chiari sintomi di stress;
- Leung ha dimostrato che il perdurare di un versamento contenente porfirina ( pigmento colorato che entra nella costituzione dell'emoglobina, della clorofilla, dei citocromi)dalla ghiandola Harderiana dei topi è legato al livello del campo al quale i topi sono esposti. La presenza dell'essudato (materia semiliquida di produzione patologica che fuoriesce dai tessuti infiammati), detto cromodacriorrea, è un indicatore di stress in molti roditori, inclusi topi e criceti;
- Leung ha anche asserito che l'esposizione ad un campo di intensità di 39 kV/m riduce o elimina il cambiamento nei livelli di prolattina in circolo che in genere si manifesta in risposta ad una condizione di stress. Quindi in un animale esposto viene danneggiata la capacità di rispondere correttamente ad uno stress ulteriore.
Sono stati condotti degli esperimenti su animali per capire come un campo alle ELF possa agire sulla ghiandola pineale che si trova in posizione molto interna nel cranio; i risultati a cui si è giunti sono stati i seguenti:
- i pinealociti in una coltura (fuori dal cranio) rispondono ai cambiamenti di campo magnetico locale;
- Bowers ha ipotizzato che la funzione pineale può essere danneggiata da cambiamenti molto lievi nella segnalazione neuronale. Il meccanismo per il quale un campo alle ELF interagisce direttamente con il sistema nervoso alterando gli aspetti dell'informazione neuronale elettrica trasmessa tra i neuroni, prende il nome di accoppiamento per gangli.
- i pulcini e i roditori percepiscono la presenza di campi magnetici attraverso dei recettori che si trovano all'interno della testa, in prossimità degli occhi (le risposte a cambiamenti di campo sono evidenziate analizzando le variazioni del contenuto di melatonina nella retina e nella ghiandola pineale: Olcese, 1988).
Si è finora dimostrato che esiste una diretta interazione tra l’epifisi e i campi alle ELF. Da alcune osservazioni si è visto che i topi maschi erano maggiormente colpiti da cancro in seguito all’esposizione a campi alle ELF, ma è comunque azzardato asserire che l’esposizione alle ELF contribuisca ad aumentare il rischio di tumore. Per approfondire questi aspetti e determinare gli effetti sugli esseri umani esposti a campi normalmente presenti in ambiente domestico sono iniziati degli studi appositi. Si è concentrata l’attenzione sull’uso di termocoperte; l'uso di termocoperte è un caso particolare di esposizione a campi alle ELF in ambiente residenziale. Sia il campo elettrico che quello magnetico che si generano al di sotto delle termocoperte sono tra i più alti misurati tra le mura domestiche e l'esposizione ad essi avviene, principalmente, di notte quando l'epifisi è attiva. Il campo magnetico e quello elettrico sono facilmente misurabili in questo caso e, poichè stiamo considerando frequenze basse, vale l'approssimazione quasi-statica ed il campo magnetico e quello elettrico si possono considerare separatamente.
La Fig.4 è un grafico dell'esposizione a campi magnetici nel periodo delle 24 ore, includendo il tempo passato sotto la termocoperta (10:00 p.m. - 7:00 a.m.); i picchi che si possono notare durante il giorno sono per lo più dovuti all'esposizione a campi nel tragitto fino a e da scuola (il soggetto è un bambino di 8 anni).
![]()
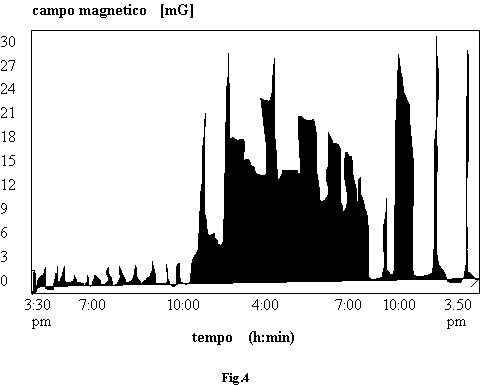
Studi a questo riguardo sono stati condotti da Wilson a partire dal 1988: sono stati presi in considerazione due tipi di termocoperte: quello convenzionale (con interruttore di sicurezza) e quello con filo continuo polimero (CPW) che ha un duty cycle più corto e presenta un campo magnetico più intenso del 50 % rispetto al primo. La prima misura che è stata fatta per determinare gli effetti del campo sulla funzionalità della ghiandola pineale è stata quella sull’escrezione notturna del 6-OHMS urinario; essendo presenti, in questo tipo di secrezione, profonde differenze da individuo a individuo, gli esperimenti sono stati strutturati in modo tale che i volontari funzionassero come auto controllo. I risultati raccolti hanno mostrato una variazione dei valori negli ultimi due dei tre periodi di esposizione: come si vede dalla Fig.5, non ci sono cambiamenti tra la preesposizione e l'esposizione nel periodo due (settimane 1-5), mentre si nota un vistoso decremento nei valori nel periodo tre (settimane 6-10); i valori mostrano un picco di "contraccolpo" quando l'esposizione cessa.
. .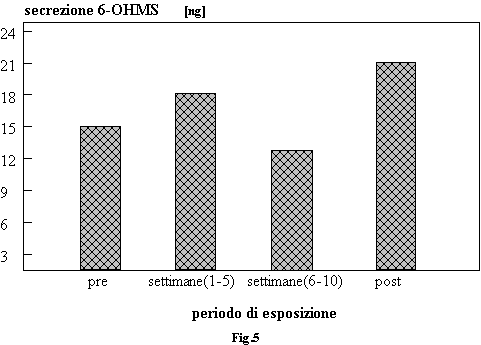
La Fig.6 mostra i dati raccolti dal volontario #2045.
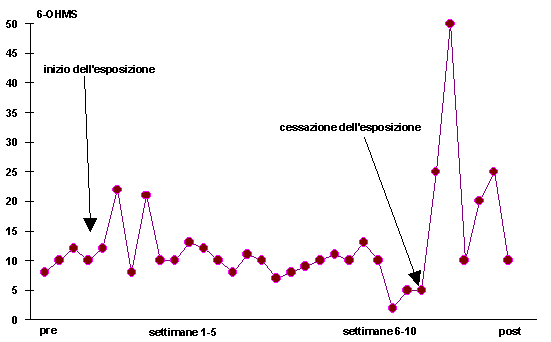 periodo di esposizione
periodo di esposizione
Fig.6
Non sono state ancora individuate le caratteristiche dei campi elettrico e magnetico generati dalle termocoperte CPW apparentemente responsabili delle variazioni nell'escrezione notturna di 6-OHMS.
Le osservazioni finora fatte sono:
- ci sono piccole differenze tra il campo elettrico generato dalle termocoperte convenzionali in AC e quello generato dalle termocoperte CPW (sempre in AC);
- l'ampiezza del campo magnetico era più alta del 50% nelle termocoperte CPW;
- Graham (1988) osservò un aumento degli effetti del campo elettrico sull'uomo quando tale campo veniva acceso e spento rapidamente;
- le termocoperte CPW si accendono a spengono ad una velocità all'incirca doppia rispetto a quelle convenzionali.
Non si riscontrano variazioni significative nell'escrezione di 6-OHMS in soggetti esposti a campi prodotti da termocoperte convenzionali, questo può significare che la riduzione dei campi o i cambiamenti nel duty cicle associato a queste possono ridurre o eliminare gli effetti sulla ghiandola pineale.