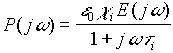 (1.1)
(1.1)
CAPITOLO 1
INTERAZIONI TRA CAMPO ELETTROMAGNETICO E SISTEMI BIOLOGICI
1.1 Proprietà dielettriche dei materiali biologici
Le proprietà dielettriche dei materiali sono descritte dalla permittività, o costante dielettrica, e e dalla conducibilità s.
L'applicazione di un campo elettrico esterno su un mezzo induce, al suo interno, un campo, il cui andamento è il risultato macroscopico della media dei campi microscopici che, localmente, si stabiliscono nel mezzo stesso; la conoscenza del campo locale permette di modellare la risposta del materiale biologico, nel suo complesso, al campo elettrico incidente.
Quando si applicano campi elettrici statici a mezzi omogenei ed isotropi, la costante dielettrica è un numero reale e rappresenta la risposta del materiale alla stimolazione esterna.
Nel caso di campi elettrici variabili nel tempo i meccanismi di polarizzazione all'interno del dielettrico possono trovarsi in ritardo rispetto all'eccitazione; in particolare, se il campo ha un andamento a gradino, il materiale risponde con un vettore di polarizzazione del tipo
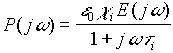 (1.1)
(1.1)
dove i indica la specie dipolare in esame.
La risposta del materiale, nel tempo, è visualizzata in figura 1.1
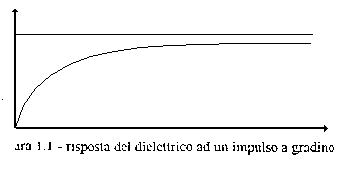
figura 1.1 - risposta del dielettrico ad un impulso a gradino
Il vettore di induzione elettrica D assume l'espressione
![]()
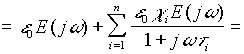 (1.2)
(1.2)
![]()
da cui si evince che la costante dielettrica è un numero complesso, la cui parte reale, e', è la risposta del materiale in fase con il campo incidente, mentre la parte immaginaria, e", tiene conto dei termini in ritardo di fase, dunque delle perdite.
La conducibilità del materiale è data dalla
![]() (1.3)
(1.3)
dove il primo addendo è la conducibilità dovuta alla corrente di spostamento, mentre il secondo rappresenta la conducibilità ionica, causata dallo scorrimento degli ioni liberi sotto l'azione del campo esterno.
Esiste un legame tra il fattore di perdita, e" = Im [e], e la conducibilità del materiale, s, dato dalla
 (1.4)
(1.4)
I meccanismi di polarizzazione che avvengono nei materiali biologici in seguito all'applicazione di campi elettrici variabili nel tempo possono essere caratterizzati dalla variazione, in frequenza, delle proprietà dielettriche; il diagramma risultante, detto anche spettro dielettrico, è rappresentato in figura 1.2.
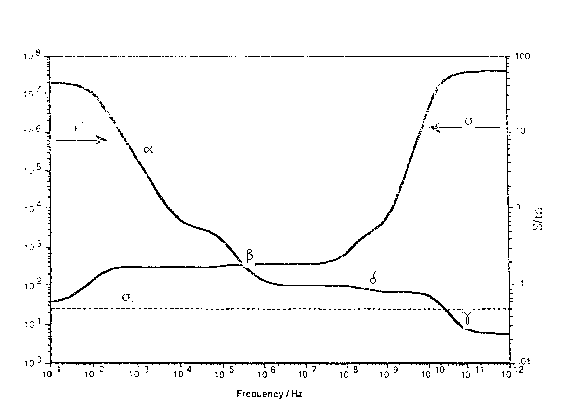
figura 1.2 - Spettro dielettrico di un materiale ad alto contenuto di acqua
In esso sono chiaramente distinguibili tre principali regioni di rilassamento, a, b, g, rispettivamente alle basse, medie ed alte frequenze, unitamente ad una quarta, d, meno evidente, a cavallo tra medie ed alte frequenze. Il rilassamento è il ritardo della polarizzazione nel dielettrico, causato dall'inerzia delle molecole del materiale stesso, in presenza di un campo incidente. Il rilassamento è tanto maggiore quanto maggiori sono la frequenza del campo incidente e le dimensioni del dielettrico; lo spettro dielettrico può, quindi, essere espresso come la somma dei rilassamenti corrispondenti alle diverse polarizzazioni, secondo la nota equazione di Debye
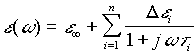 (1.5)
(1.5)
dove![]() ,
, ![]() è
il salto dielettrico relativo alla singola dispersione,
è
il salto dielettrico relativo alla singola dispersione, ![]() è
la costante di tempo del singolo rilassamento e m rappresenta il numero
totale delle dispersioni.
è
la costante di tempo del singolo rilassamento e m rappresenta il numero
totale delle dispersioni.
La complessità della struttura e della composizione del materiale biologico è tale che ogni regione di rilassamento subisce un allargamento dovuto a diversi contributi; questo fenomeno è tenuto in conto dall'equazione di Cole - Cole
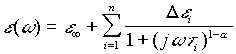 (1.6)
(1.6)
ove a , detto anche parametro di distribuzione, è una misura dell'allargamento della zona di rilassamento.
1.2 Parametri di esposizione: il SAR
Una volta definito il comportamento dielettrico dei materiali biologici in presenza di campo elettrico esterno, è possibile classificare tali materiali secondo tre categorie:
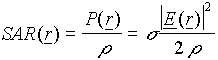 (1.7)
(1.7)
La media dei SAR locali, sull'intera massa del soggetto esposto, prende il nome di SAR medio.
Il SAR viene comunemente utilizzato, in ambito dosimetrico, per la valutazione degli effetti biologici, di tipo termico, indotti sui tessuti e per stabilire delle normative di sicurezza.
In un tessuto di un organismo vivente esposto ad una radiazione elettromagnetica le sorgenti di calore sono essenzialmente due: il complesso insieme di trasformazioni chimiche che va sotto il nome di metabolismo e l'energia elettromagnetica sottratta alla radiazione incidente. Il calore assorbito per unità di tempo, per effetto della radiazione, è proprio il SAR; indicando con WM il calore prodotto dal metabolismo nell'unità di tempo e con WL quello dissipato dal sistema termoregolatorio si può scrivere, per il generico tessuto,
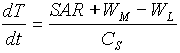 (1.8)
(1.8)
dove CS rappresenta il calore specifico del tessuto.
Entro certi limiti di esposizione il sistema termoregolatorio riesce a compensare gli aumenti di temperatura, agendo sul calore dissipato WL.
Il SAR è fortemente influenzato dalle caratteristiche della radiazione incidente sul soggetto; infatti, quando la lunghezza d'onda del campo elettromagnetico e le dimensioni del soggetto esposto diventano paragonabili, si verificano fenomeni di risonanza che danno luogo a picchi di assorbimento.
Il massimo del rilassamento delle molecole di piccole dimensioni, come l'acqua, si ha per frequenze intorno al GHz, proprio là dove si collocano le telecomunicazioni cellulari mobili, e gli organi a maggior rischio sono quelli di testa, collo e mano, più esposti alla radiazione per la vicinanza alla sorgente; i tessuti a più alta conducibilità, cioè quelli ad elevato contenuto di acqua, in essi presenti sono quelli del cervello e degli occhi che, quindi, sono da considerarsi a maggior rischio, perché l'alta conducibilità si sovrappone ad una scarsa vascolarizzazione e, quindi, ad una minore efficienza termoregolatoria.
1.3 Esposizione agli apparati mobili di telecomunicazione
I sistemi radiomobili permettono la comunicazione tra utenti in movimento, caratteristica, questa, che ha incentivato il considerevole sviluppo negli ultimi venti anni delle comunicazioni tra apparati portatili, a partire da quando, sul mercato statunitense, sono comparsi i primi modelli di telefono cellulare.
Il termine cellulare deriva dalle cellule in cui viene suddiviso il territorio; in ognuna di esse opera una stazione ricetrasmittente che consente il collegamento tra la rete telefonica ed il terminale interessato.
Attualmente i sistemi di comunicazione utilizzati sono, a livello nazionale, il TACS (Total Access Comunicativo System) e, su base europea, GSM (Global System for Mobile communication). Quest'ultimo è un sistema numerico di elevate prestazioni adottato dal 1994 per le comunicazioni tra i 70 Stati firmatari di un apposito "Memorandum of Understanding"; in particolare è generalizzata la sua adozione per gli Stati della Comunità Europea, mentre anche in altre vaste aree, quali l'Australia e parte dell'Asia, ne è in corso l'adozione.
Gli apparati operano nella gamma da 872 a 905 MHz in trasmissione e da 917 a 950 MHz in ricezione; in previsione del vivace incremento della domanda, è in corso l'adozione anche della gamma attorno a 1.8 GHz.
La crescente utilizzazione quotidiana di questo tipo di dispositivi da parte di un elevatissimo numero di persone ha evidenziato la necessità di valutare i possibili rischi per la salute conseguenti all'assorbimento dell'energia elettromagnetica da parte dell'utente; bisogna, infatti, tenere presente che normalmente i telefoni cellulari presentano una struttura radiante che opera nelle immediate vicinanze della testa dell'utilizzatore, le cui dimensioni, per effetto dei fenomeni di risonanza, comportano un assorbimento di energia elettromagnetica alle frequenze UHF (300 MHz - 3 GHz) particolarmente elevato rispetto a quello tipico per frequenze inferiori.
Per valutare se il telefono cellulare è
dannoso alla salute si deve affrontare una questione di dosimetria, numerica
e sperimentale: da un lato, si calcola il SAR, medio e di picco, nella
testa di un utilizzatore, mediante metodi numerici di simulazione automatica,
quali FDTD (Finite Differences Time Domain) e MoM (Method of Moments) al
variare delle condizioni di esposizione, dall'altro, mediante esperimenti
di laboratorio, si effettuano misure di SAR su fantocci dielettrici equivalenti,
cioè fantocci che rappresentino, dal punto di vista delle costanti
dielettriche, tessuti reali.