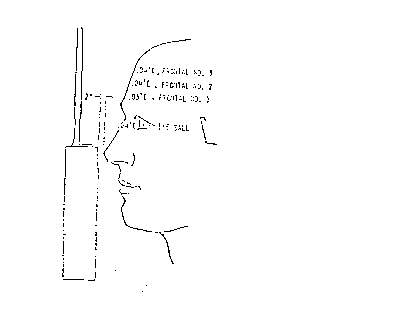
CAPITOLO 5
L'EVOLUZIONE DELLE MISURE SPEIMENTALI
I banchi di misura realizzati, in generale, hanno lo scopo di valutare la distribuzione del SAR e di individuare i suoi valori di picco all'interno di fantocci, più o meno antropomorfi, che simulino totalmente o parzialmente il comportamento del corpo umano esposto ad energia elettromagnetica.
Si è avuta, nel tempo, una focalizzazione "per approssimazioni successive" dell'obiettivo: l'analisi del campo elettromagnetico si è spostata da analisi di campo lontano ad analisi di campo vicino, si è sempre più evidenziata l'inutilità di lavorare su fantocci antropomorfi, l'irradiazione si è trasformata da totale a parziale, incentrando gli studi sulla testa e, al massimo, sul collo e sulla mano che sorregge il telefono durante l'uso.
Oggi, poi, l'analisi si sta estendendo anche ad aspetti di compatibilità elettromagnetica con dispositivi d'altra natura, quali apparecchi elettromedicali (defibrillatori, pacemakers, ...), come verrà evidenziato nel seguito.
Risalgono al 1978 i primi studi sull' esposizione in campo vicino, originato da un sistema radiante a circa 800 MHz, di fantocci composti di tessuti con proprietà dielettriche simili a quelle dei tessuti biologici umani, per opera di Balzano e del suo gruppo di lavoro, e riguardano rilievi di profili di temperatura, effettuati senza utilizzare sonde di campo elettrico.
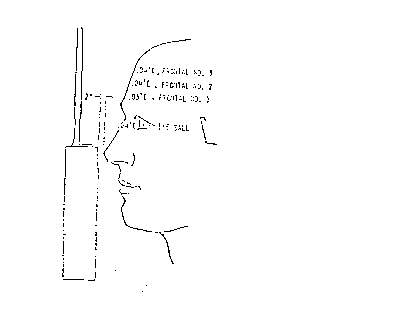
figura 5.1 - profilo di temperatura
Non era seguito il criterio del worst-case, ma un compromesso, condizionato alla considerazione che, per distanze maggiori di quelle adottate nel setup sperimentale, è impossibile realizzare dei profili di temperatura come quello della figura soprastante, mentre a distanze minori il dispositivo radiante non si trova in condizioni riconducibili a quelle di normale uso.
Emerge la necessità di porsi in condizioni sperimentali di campo vicino, sia per approssimare meglio le condizioni di esposizione reali, sia per poter meglio esaminare gli effetti di irradiazione parziale del corpo.
All'inizio degli anni '80 (Iskander et al., 1981), la procedura sperimentale consiste ancora nella misura dell'incremento di temperatura dopo l'esposizione ad energia elettromagnetica, per un determinato intervallo di tempo, in un fantoccio di soluzione salina simulante il tessuto muscolare.
I campi irradiati vengono misurati con sonde di campo elettrico, calibrate in celle TEM, e di campo magnetico, mentre il profilo di temperatura nel fantoccio viene ricavato tramite una sonda di temperatura a fibre ottiche, non perturbante; il fantoccio non è necessariamente antropomorfo.
Viene determinato che, a parità di condizioni al contorno, il tasso di assorbimento di potenza in campo vicino è inferiore a quello ottenuto in condizioni di campo lontano.
A partire dalla metà degli anni '80 fanno la loro comparsa sistemi di scansione gestiti da computer, più efficienti nell'analisi della distribuzione di campo elettrico nei corpi dissipativi e nella mappatura dell'intensità di campo elettrico all'interno di un fantoccio, antropomorfo o meno, di corpo umano esposto, in campo vicino, ad energia elettromagneticasi tenta di avvicinarsi sempre più alle reali condizioni di esposizione.
Per l'esposizione in campo vicino si ha che:
1) la distribuzione spaziale di SAR è altamente non uniforme, in ogni situazione di polarizzazione del campo incidente;
2) il SAR diminuisce esponenzialmente con la distanza della sorgente radiante dalla superficie esposta, almeno fino a distanze dell'ordine di 10 cm; a questa distanza l'onda è attenuata di circa 15 dB e l'andamento dell' attenuazione è molto vicino a quello di un'onda piana incidentesu uno strato semiinfinito di tessuto;
3) la distribuzione spaziale del SAR dipende fondamentalmente da posizione e polarizzazione dell'antenna, mentre il SAR medio è funzione del guadagno di antenna e della distanza della sorgente dal corpo. Ovviamente il tipo di antenna influenza ambedue i SAR;
4) la non uniformità della distribuzione di SAR in campo vicino implica che, sebbene il SAR medio sia al di sotto dei limiti suggeriti dalle norme, 0.4 W/Kg, si possono avere dei picchi sul SAR locale superiori al limite di sicurezza, dettato dalla normativa ANSI del 1982, di 8 W/Kg.
Nel 1985 si cominciano a fare studi su campi elettromagnetici a 915 MHz (M.A. Stuchly et al.), utilizzando dei fantocci omogenei e si nota che, in campo vicino ed a parità di potenza di ingresso all'antenna, si ottiene nella testa un SAR medio di valore circa triplo dell'omologo per tutto il corpo.
Si nota, infatti, che a 915 MHz, per le esposizioni in campo vicino, la maggior parte dell'energia viene assorbita nella testa.
Emerge, però, anche il sospetto che in campo vicino il SAR medio totale possa non costituire una misura dosimetrica appropriata, visto che la maggior parte della potenza viene assorbita da un volume non più grande di un decimo del volume totale.
Andando a ripetere gli esperimenti su modelli eterogenei, si ottengono risultati molto simili: per tutte le frequenze di prova, dai 300 MHz a 915 MHz, e per ogni orientamento dell'antenna, la maggior parte dell'energia è assorbita nel volume che si trova nelle immediate vicinanze del feed point dell'antenna.
Ci sono delle differenze, però, sui valori di SAR: nel caso di fantocci eterogenei, essi risultano da 2 a 5 volte maggiori rispetto al caso di modelli omogenei; comportamento, questo, che può essere giustificato dai diversi valori conducibilità (maggiori nel caso di fantoccio omogeneo).
In materia di normativa di sicurezza, nel 1989 viene suggerito di includere nella normativa ANSI vigente (ancora quella del 1982) una clausola che escluda la possibilità di avere potenze in trasmissione maggiori di 7 W, limite al di là del quale la probabilità di superare i limiti di sicurezza di SAR diventa molto elevata.
Nel 1992 N. Kuster e Q. Balzano, al termine di un loro lavoro, raggiungono la conclusione che le norme di sicurezza devono essere riviste, poichè la clausola di esclusione dei dispositivi trasmittenti con potenze maggiori di 7 W non è sempre coerente con il limite di sicurezza per popolazioni controllate imposto dall'ANSI sul picco locale di SAR, 8 mW/g.
Ai giorni nostri, nel 1995, V. Anderson e K.H. Joyner pubblicano un articolo riguardante valori di SAR misurati in una sagoma avente la forma di un cranio umano esposto a RF prodotta da telefoni cellulari analogici.
Durante le misure i telefoni sono stati posizionati lungo la testa nella posizione di tipico impiego e configurati per trasmettere alla massima potenza, 0.6 W nominali.
Il fantoccio è un modello eterogeneo, perchè presenta una struttura multistrato simulante cervello, muscolo, occhio e pelle.
Sono state condotte misure di campo elettrico indotto all'interno del fantoccio, nell'occhio più vicino al telefono e, lungo una superficie laterale, attarverso il cervello, dal centro alla parte più prossima al telefono. Il SAR, infine, è stato determinato dai valori di campo elettrico, con un'incertezza totale sulla misura di +/- 1.6 dB.
Sebbene ci si trovi di fronte a stime del caso peggiore (worst case), i valori di SAR ottenuti sono ancora al disotto dei limiti sui picchi spaziali raccomandati dalle linee guida statunitensi ed australiane (IEEE Standards Coordinating Committee 28 (1991), C95.1-1991 e Standards Australia (1990), AS22772.1-1990).
Una dettagliata analisi termica, inoltre, indica un aumento massimo della temperatura dell'occhio e del cervello inferiore alle normali fluttuazioni termiche presenti, ciò escludendo ogni possibilità di danni fisiologici.
Nel corso dello "State of the Science Colloquium", tenutosi a Roma dal 13 al 15 novembre 1995 sotto l'egida del WRT (Wireless Research Technology), è stata, soprattutto negli interventi di O.P. Gandhi e C. Gabriel, confermata la tendenza a semplificare quanto più possibile la morfologia dei fantocci, in quanto i risultati ottenuti con fantocci "semplici" sono sufficientemente in accordo con quelli provenienti da fantocci "complessi".
In particolare, è stato evidenziato dalla D.ssa Gabriel che, alla frequenza di 900 MHz, le diversità delle proprietà dielettriche nelle varie regioni del cervello sono trascurabili: in prima approssimazione, si hanno risultati praticamente coincidenti, sia che si adottino modelli omogenei che eterogenei.
Per porsi in condizioni di worst case è, dunque, sufficiente considerare fantocci non antropomorfi, geometricamente semplici ed omogenei, riservandosi di utilizzare modelli ben più complessi, nella forma e nella composizione, solo per analisi ed esperimenti volti ad analizzare prestazioni specifiche di blocchi particolari del banco di misura.
La tendenza ad abbandonare il modello antropomorfo è generalizzata ed è giustificata da due fondamentali ragioni:
• il modello antropomorfo è più dipendioso, a fronte di risultati sperimentali molto simili, di modelli caratterizzati da geometria più elementare, come ad esempio un parallelepipedo;
• in questo modo, si risponde ad un approccio più adatto a stabilire
delle condizioni di riferimento che possano rappresentare il worst case,
cioè quanto più possibile svincolate dalla fisionomia di
un particolare volto umano.