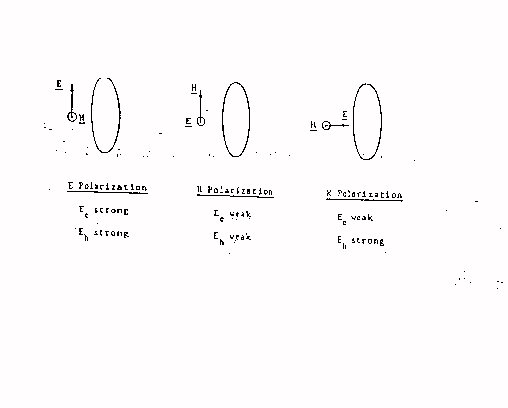
6.1 - Schwan ( 1953 )
6.2 - ANSI ( American National Standard
Instirute )
6.2.1 - Prima normativa
americana ( ANSI 1974 )
6.2.2 - Standard ANSI
1982
6.2.2.1
- Critica di Gandhi ( 1986 )
6.2.2.2
- Critica ed osservazioni di J. C. Lin
6.2.3 - Standard ANSI
1992
6.2.4 - Confronto
fra i limiti di ANSI 1982 e ANSI 1992
6.2.5 - IEEE C 95.1
- 1992
6.3 - ACGIH 1988 ( American Conference
of Governmental Industrial Hygienists )
6.4 - Confronto fra i limiti di ANSI 1982
e ACGIH 1988 .
6.5 - NIOSH 1978 ( National Institute for
occupational Safety and Health )
6.6 - Confronto fra i limiti di ANSI 1978
e ANSI 1982
La prima proposta di standard fu fatta da Schwan nel 1953
. Egli fece degli esperimenti sugli animali e da questi trasse delle conclusioni
di tipo fisiologico : il tasso massimo di lavoro che può essere
sostenuto per un certo numero di ore richiede al corpo di dissipare circa
750 W , mentre il totale assorbimento di 100 W/m2 ( ossia 10 mW/cm2 ) incidente
su campioni di corpo di estensione di 0.7 m2 determinerebbe un calore aggiunto
di 70 W , che risulta piccolo se paragonato con quello determinato
dalla più semplice attività manuale ; ed è infatti
inferiore rispetto al tasso metabolico a riposo .
Il livello di 100 W/m2 è 10 volte inferiore
rispetto ai livelli di esposizione che creano disturbi ai testicoli e agli
occhi ( che sono i due organi più sensibili agli effetti termici
).
In questo standard si è fatta l' assunzione che
il riscaldamento dei tessuti del corpo ( effetto termico ) sia la conseguenza
più importante dell' assorbimento di energia alle RF . Lo standard
americano propone di mantenersi a livelli più bassi se ci sono altre
fonti di calore e consente di alzarli in condizioni di freddo intenso.
In conclusione : Schwan sostenne che una potenza superiore a
100 W/m2 potesse essere rischiosa e pose tale valore come limite ( costante
) , indipendentemente dalla frequenza .
6.2 ANSI ( American National Standards Institute )
Gli studi di Schwan furono portati avanti e vennero esaminati
gli effetti comportamentamentali e biologici degli animali sottoposti alle
RF e MW (attività agitata , sospensione del lavoro o sua diminuzione
, minore resistenza , percezione dell' esposizione ai campi , comportamento
aggressivo ).
Un passo importante (fatto tra il 1970 e il 1972 ) è quello
relativo alla definizione di SAR ( SAR = Specific Absorption Rate ) .
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
6.2.1 Prima normativa americana ( ANSI 1974 )
Dagli studi fatti l' ANSI ha trovato il valore di SAR medio
[ dovuto ad un' esposizione acuta ( ossia ad elevata
potenza e breve durata ) all' energia elettromagnetica ] per il quale non
si hanno danni sulla salute degli animali ; tale valore scalato alle
dimensioni umane risulta pari a 4 W/Kg e siccome esposizioni
prolungate possono creare danni si è deciso di ridurlo di un fattore
10 scendendo a 0.4 W/Kg.
L'intervallo di esposizione è di 6 minuti perché
è il tempo necessario al sistema termoregolatorio per smaltire
un SAR di 0.4 W/Kg ; la densità di potenza massima permessa è
risultata essere pari a 10 mW/cm2 .
Negli studi del "72 ( su cui si fondava la normativa del
"74 ) il livello di 10 mW/cm2 era stato considerato costante durante tutto
l'intervallo di esposizione , ma studi successivi ( fatti nel "76-"78-"79
) mostrarono la presenza di un fenomeno di risonanza , ossia : i rischi
inerenti alla salute ( relativi all'esposizione alle RF e MW ) sono direttamente
collegati all'assorbimento e alla distribuzione dell'energia nel corpo
, che sono fattori dipendenti a loro volta dall'orientazione del corpo
, dalla frequenza e dalla polarizzazione dell' onda incidente ; quindi
, a parità di energia incidente , la quantità di energia
assorbita non è la stessa a tutte le frequenze , ma esistono degli
intervalli in cui l'assorbimento di energia è molto elevato ( ciò
deriva dalla natura dei tessuti e dal loro contenuto di acqua ) .
Dal 1974 in poi , inoltre , c'è stata l' elaborazione
dell' uomo nei vari modelli : uomo a sfera , a ellissoide prolato , a cubetti
. Per i tre tipi di polarizzazione , nel caso di modello sferoidale , risulta
:
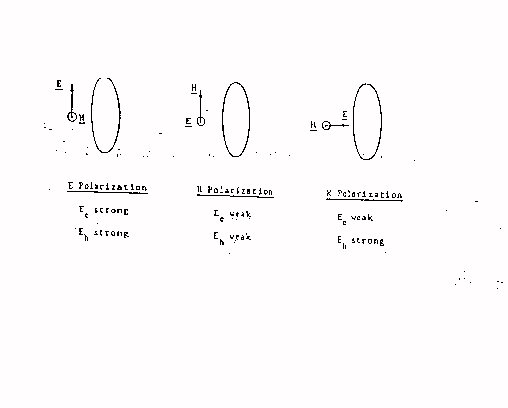
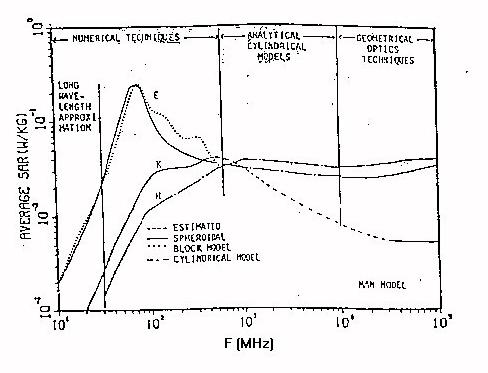
Sia la teoria sia gli esperimenti hanno mostrato che l'assorbimento
a RF e MW nel modello a sferoide prolato raggiunge un massimo quando l'asse
del corpo è parallelo al vettore campo elettrico ed è pari
, approssimativamente , a 4/10 della lunghezza dell' onda incidente
( a RF e MW ) .
Esponendo uomini di diverso peso e di diversa altezza ad una
potenza media incidente pari a 10 mW/cm2 si ha :
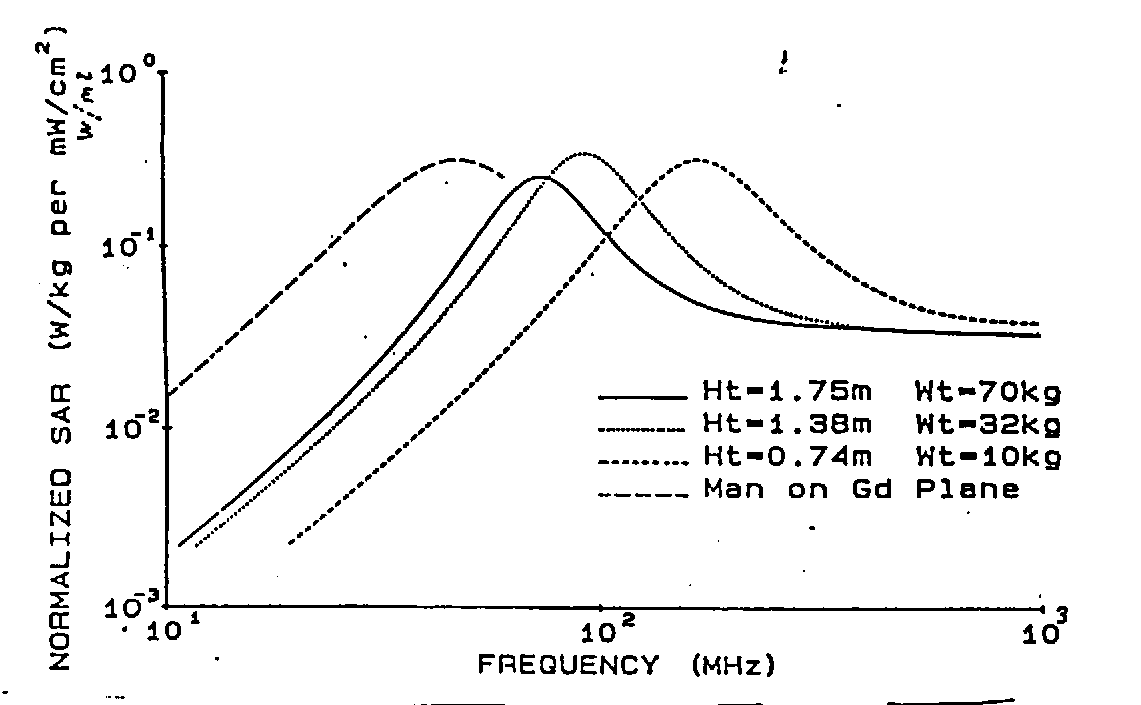
Si vede che la frequenza di risonanza sarà tanto maggiore quanto più piccole sono le dimensioni del corpo ; inoltre un uomo con i piedi ( nudi ) a terra ( Man on Ground Plane ) ha una frequenza di risonanza più bassa rispetto ad un uomo normalmente esposto ( e anche rispetto ad un bambino ) . Questo concetto è stato tenuto in considerazione per le normative americane del 1982.
Basandosi sulle caratteristiche di assorbimento nel corpo
umano , il range di frequenza delle RF e delle MW può essere suddiviso
in quattro regioni ( Schwan 1982 ; IRPA 1988 ) :
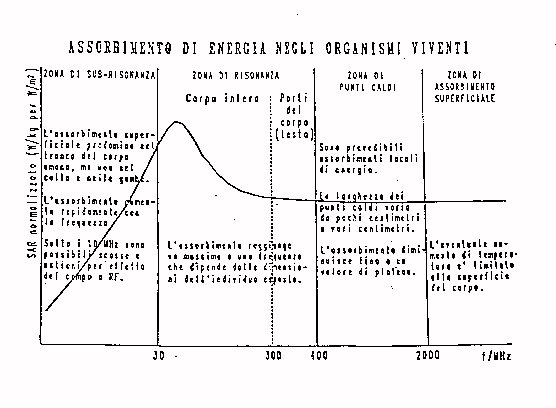
a) ZONA DI SUB-RISONANZA ( frequenze inferiori ai 30 Mhz ) : predomina
l'assorbimento per il tronco umano , ma non per il
collo e le gambe ; l'energia assorbita aumenta rapidamente
all'aumentare della frequenza . Sotto i 10 Mhz sono possibili scosse e
ustioni per effetto del campo a RF.
b) ZONA DI RISONANZA ( frequenze che vanno da 30 a 400 Mhz ) : l'assorbimento
raggiunge un massimo ad una frequenza che dipende
dalle dimensioni dell' individuo esposto , da 30 a 300 Mhz
risuona l' intero corpo , da 300 a 400 Mhz risuonano solo alcune
parti del corpo quali la testa .
c) ZONA DI PUNTI CALDI ( frequenze che vanno da 400 Mhz a 2-3
Ghz ) : l'assorbimento significativo di energia localizzata è prevedibile
ad una densità di potenza incidente di circa 100 W/m2.L'assorbimento
di energia diminuisce quando la frequenza aumenta , fino ad arrivare
ad un valore di plateau e la larghezza della zona degli hot
spot va da diversi centimetri ( a 915
Mhz ) a circa 1 cm ( a 3 Ghz ) .
d) ZONA DI ASSORBIMENTO SUPERFICIALE ( frequenze superiori a
2 Ghz ) : l'eventuale aumento di temperatura è limitato
alla superficie del corpo .
6.2.1.1 Limiti di ANSI 1974
Un problema dipende dal fatto che si può essere esposti a più sorgenti contemporaneamente e l' ANSI 1974 considerò solo il caso in cui uno o più trasmettitori si trovassero nello stesso range di frequenza ( come mostrato in figura ) :
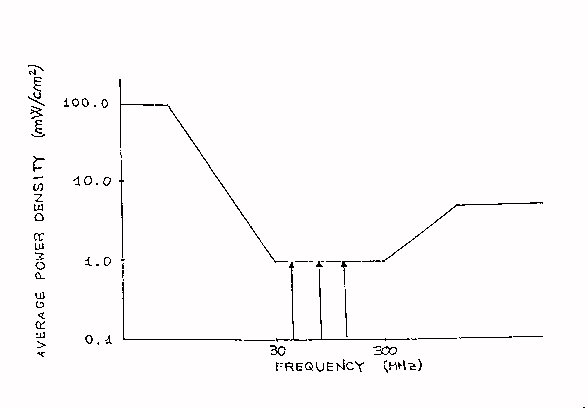
In questo caso calcolare se la potenza incidente complessivamente
supera la soglia consentita in questo range è molto facile ( basta
applicare il teorema di Parseval ) : si fa la somma dei segnali e si verifica
che tale somma si trovi al di sotto dei limiti consentiti.
Il problema nasce quando si è sottoposti a due o più
sorgenti che si trovano a frequenze diverse ( come nel caso rappresentato
in figura ) :
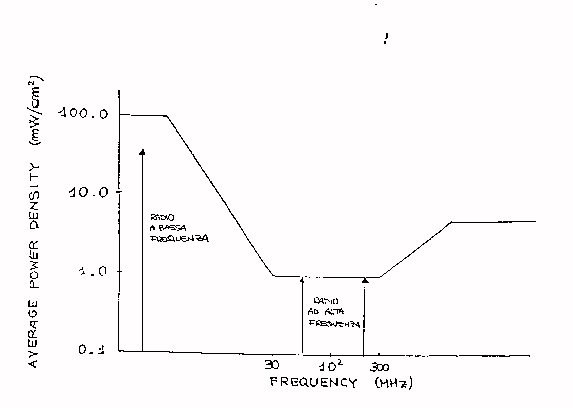
In questo caso bisogna fare una sorta di normalizzazione ( ed è ciò che è stato fatto dalla nuova normativa ) , nel seguente modo :
1) si calcolano i rapporti livello sperimentale-livello di soglia
per ciascun segnale ,
2) si esprimono tali rapporti in forma percentuale e si sommano i
valori percentuali ottenuti ,
3) se la percentuale ottenuta complessivamente è maggiore
o uguale al 100% , il livello incidente complessivamente è al
di sopra della soglia , altrimenti non si hanno pericoli .
In formule ( nel caso particolare di tre sorgenti ) :
T1 T2
T3
--- + ---- + .--- <=
1
(10)
N1 N2
N3
dove :
T1 , T2 , T3 sono i
trasmettitori
N1 , N2 , N3 sono le
normative relative a ciascun trasmettitore ( che si trova ad una
determinata frequenza )
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
In base alle considerazioni fatte si decise di mantenere
fisso il livello del SAR ( 0.4 W/Kg ) e di non fissare più la potenza
incidente ( costante e ) pari a 10 mW/cm2 ( vedi figura seguente
) :
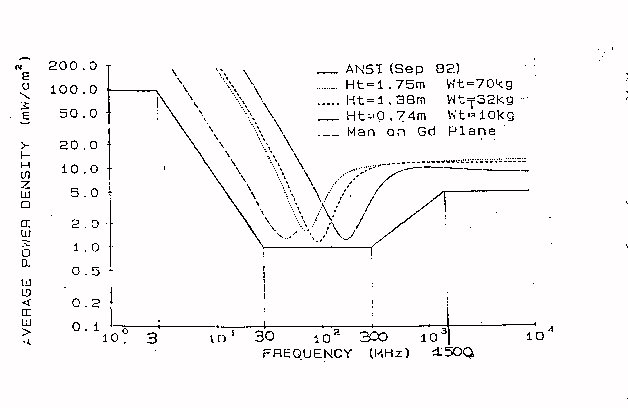
L'ANSI ha proposto il principio ALARA ( As Low As Reasonably
Achievable : basso quanto ragionevolmente possibile ) e , quindi ci
si è mantenuti al di sotto dei valori ritenuti
pericolosi ( come indicato nella figura precedente ) :
- da 300 Khz a 3 Mhz si accettano densità di potenza
fino a 100 mW/cm2 ;
- da 3 a 30 Mhz la densità di potenza scende come 1/f2 (
la curva scende rapidamente )
- da 30 a 300 Mhz la densità di potenza accettabile scende fino
ad 1 mW/cm2;
- da 300 Mhz a 1.5 Ghz la densità di potenza risale
proporzionalmente ad f ;
- per frequenze superiori ad 1.5 Ghz la densità di potenza
arriva ad un valore di 5 mW/cm2 .
I valori trovati per i limiti di densità di potenza
e di intensità di campo ( elettrico e magnetico ) sono riportati
nella tabella , valida sia per la
popolazione che per i lavoratori esposti
alle radiazioni a RF e MW :
Frequency range |
Power density |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il range di frequenza a cui la tabella fa riferimento va da 300 Khz a 100 Ghz e le esposizioni a cui si riferisce sono mediate su 6 minuti . In realtà i livelli riportati in tabella sono permessi se si può dimostrare che il SAR medio ( ossia : mediando i valori di SAR trovati nei 6 minuti ) dell' energia è inferiore a 0.4 W/Kg e il tasso di picco non supera 8 W/Kg in nessuna parte del corpo . Emissioni da dispositivi radianti inferiori a 7 W e a frequenze al di sotto di 1 Ghz sono esentate . Sopra 1 Ghz i dispositivi vengono trattati caso per caso .
Il segnale incidente può essere continuo o impulsato :
* nel caso di SEGNALE CONTINUO posso distinguere due sottocasi :
a)segnale continuo con potenza associata uniforme : l'energia ( calore
) ceduta al soggetto irradiata per 6 minuti è pari alla
potenza incidente per 6 minuti.
b)segnale continuo con potenza associata non uniforme ( esempio : segnale
modulato in ampiezza ) : consideriamo un segnale modulato in ampiezza proveniente
da una stazione trasmittente con portante modulata ad 1 Khz
( vedi figura seguente ) :
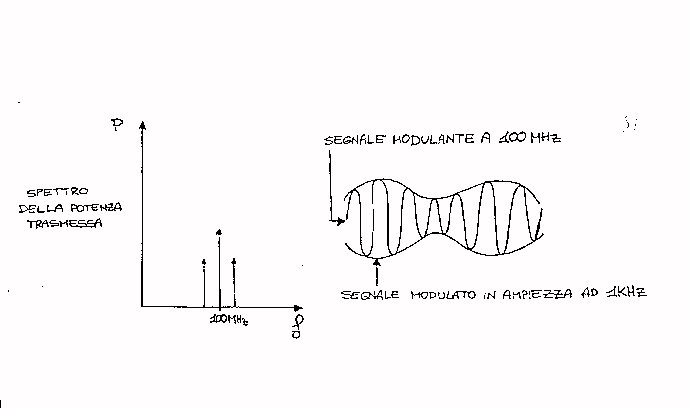
*Considerando i SEGNALI IMPULSATI e prendendo come esempio il
classico segnale radar :
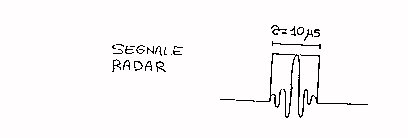
L'impulso ha durata molto breve , quindi si può
sempre considerare la durata di esposizione di 6 minuti con la condizione
di mandare un solo impulso in quest' arco di tempo.
Essendo l' impulso così stretto la potenza ad esso
associata è molto maggiore rispetto alla potenza associata al segnale
continuo ( infatti tanto minore è la durata dell'impulso tanto maggiore
sarà la potenza ad esso associata ) .
Bisogna , però , ricordare che il valore di potenza mediato
su 6 minuti non deve superare la soglia massima di 100 mW/cm2 stabilita
dalla normativa .
Si definisce come esempio la seguente tabella relativa
al legame durata dell'impulso-potenza incidente ( per un impulso
della durata di 10 microsecondi ) :
tab.6
Potenza incidente |
Intervallo di radiazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La modalità di riscaldamento del soggetto sarà
diversa , quindi , nei due casi di radiazioni continue e impulsate : nel
primo caso la potenza gli viene inviata gradualmente ( nell'arco di 6 minuti
) , nel secondo caso gli viene inviata istantaneamente .
6.2.2.1 Critica di Gandhi ad ANSI 1982 ( 1986 )
Gandhi ha messo in luce diversi problemi connessi con la
linea guida scelta dall' ANSI 1982 : tali problemi riguardano le elevate
correnti indotte a RF , l' alto valore di SAR che può essere misurato
in alcune parti del corpo e i rischi da contatto causati da oggetti esposti
per i valori di campo elettrico ( raccomandati dall' ANSI ) alle frequenze
comprese tra 300 Khz e 62.5 Mhz .
Inoltre , la linea guida ( scelta dall' ANSI ) di 50 W/m2 per le onde
millimetriche ( frequenze maggiori di 30 Ghz ) può essere vicina
alle densità di potenza che possono causare sensazioni di estremo
calore per esposizioni di tutto il corpo .
6.2.2.2 Critica ed osservazioni di J.C.Lin ( 1989 )
Lo standard ANSI del 1982 presentava dei punti critici non risolti
ed è per questo che nel 1991 fu proposto un nuovo standard , approvato
poi nel 1992 .
I punti critici esaminati nella nuova normativa sono :
1) RANGE DI FREQUENZA
2) TEMPO DI MEDIA ( si riferisce all’ intervallo di tempo in cui effettuare
le misure , cioè l’ intervallo di esposizione )
3) MPE
4) POTENZA DI PICCO ( impone una limitazione anche sul valore di picco
istantaneo , lo standard 1982 si riferiva a potenze mediate sull’ intervallo
di 6 minuti )
Nello standard 1982 si chiedeva un tempo di esposizione
di 6 minuti e 1 mW/cm2 , però si sarebbe
anche potuto considerare 3 minuti e 2 mW/cm2 , ...
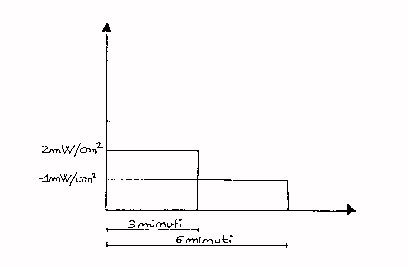
Restringendo sempre di più il tempo di esposizione ( fino
ad arrivare all'impulso ) si ottengono potenze sempre più elevate
e quindi è nata l'esigenza di fare degli studi per vedere se impulsi
di breve durata ed elevata intensità potessero essere dannosi :
Pulse duration |
Net power |
Power densit |
Power absorption |
Temp rise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alcuni di questi studi possono indurre negli animali la perdita della conoscenza e alterazioni dell’ECG (e questo per densita’ estremamente elevate ) ; si è in presenza di fenomeni termici e quindi si hanno aumenti elevati di temperatura .
Le radiazioni impulsate possono penetrare più profondamente ed essere assorbite più delle radiazioni ad onda continua aventi la stessa frequenza portante . Le armoniche di ordine più alto sono attenuate fortemente dai tessuti biologici , mentre le armoniche a frequenze più basse rispetto alla portante sinusoidale penetrano più fortemente rispetto a quelle ad onda continua .
Nella vecchia normativa ( 1982 ) i limiti , nei vari
range di frequenza , per segnali ad onda continua , vengono dati bella
tabella seguente :
Frequency range |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
Power density |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per segnali impulsati:
Exposure duration (sec) |
_________________Power_density_(W/m2)_______________________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si parte da durate di 1 ora , 1 minuto , 1 secondo , ...
e si vede che il legame che c'è tra la durata dell' impulso e la
massima potenza è inversamente proporzionale .
La capacita' dell' aria di reggere un certo campo elettrico
darà un valore di 3 x 10^6 V/m a cui corrisponde 1.2 x 10^10 W/m2
. Questo fa vedere che ( applicando la vecchia normativa ) considerando
, per esempio 10 W/m2 per 6 minuti e stringendo man mano l'impulso , si
arriva ad un punto in cui , se l'impulso è minore di 10-7 sec. ,
si superano 3.6 x 1010 W/m2 che è una situazione non realistica
la quale viene , però , consentita dalla normativa .
Se si considera un impulso rettangolare :
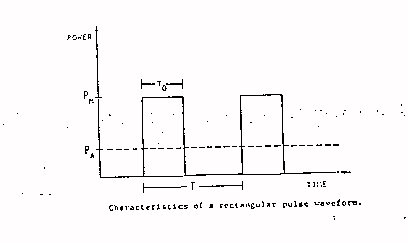
Tra le sorgenti impulsive ci sono quelle radar ( che possono
raggiungere picchi dell'ordine dei GW ) , acceleratori nucleari di particelle
e simulatori di esplosioni nucleari .
Nella tabella che segue sono rappresentati generatori
di segnali di potenza dell'ordine dei MW :
Frequency |
Peek Power |
Generating Device |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La forma del campo elettrico del segnale EMP è mostrata nella figura seguente :
fig20

Numerosi effetti somo stati rilevati negli ultimi anni in seguito
ad esposizioni a singolo impulso : esposizioni di
teste di animali di laboratorio e soggetti
umani a radiazioni alle MW pulsanti determinano sensazioni acustiche nei
soggetti esposti . I risultati ottenuti indicano che c’è una bassa
probabilità che i fenomeni di udito alle MW siano determinati da
un’ interazione degli impulsi direttamente con il nervo cocleare o con
neuroni in strutture più interne del condotto uditivo , ma c’è
una probabilità più elevata che l’ energia impulsata
a MW provochi un’ onda termoelastica di pressione sui tessuti soffici che
attiva i recettori interni dell’ orecchio .
Sebbene la reazione al fastidio dovuta ad impulsi a MW non sia
stata esplicitamente valutata su uomini o animali, gli studi hanno dimostrato
che i topi da laboratorio trovano l’effetto uditivo dovuto alla MW sufficientemente
fastidioso al punto che si sentono motivati ad evitare l’esposizione
.
Un problama che rimane è il seguente : i fenomeni di
udito determinati dalle MW sono un rischio per la salute dell’ individuo
esposto ?
tab.11
Exposure duration |
Net Power |
Incident Power* |
Brain absorption |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esposizioni sia di animali in laboratorio che di uomini alle
radiazioni a MW impulsate possono dare risposte sia fisiologiche che psicologiche
al soggetto esposto . Inoltre , questi effetti possono verificarsi per
livelli di potenza incidente che si trovano al di sotto dei limiti ANSI
1982 per la sicurezza delle persone esposte :
tab.12
Response |
Exposure duration(sec) |
Incident Power(W/m2) |
Peek SAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebbene l’ effetto del potenziale biologico di impulsi elettromagnetici
(EMP ) sia stato rilevato da qualche tempo , la sua importanza è
stata riconosciuta solo recentemente .
Nonostante ci sia ancora molto da studiare circa gli effetti
biologici di EMP , è chiaro che tali effetti sono molto diversi
da quelli dovuti a radiazioni a CW , al punto da implicare significative
interazioni neurofisiologiche . Nel modello non lineare della membrana
di Hodgkin ed Huxley la densità di corrente indotta in un tessuto
biologico da un impulso EMP ( gaussiano , con una densità di energia
equivalente massima permessa dall’ ANSI 1982 ) avrebbe prodotto una grande
alterazione nel restante potenziale di eccitazione nella membrana cellulare
. Pare che potenziali d’ azione possano essere generati da impulsi di larghezza
di 1 msec. ed intensità di campo elettrico incidente di 400 KV7m
(con soglia di eccitazione del potenziale inversamente proporzionale alla
larghezza dell’ impulso ) , ma il significato fisiologici di ciò
è oscuro (Bernardi e D’Inzeo , 1984 ) .
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
Una prima novità rispetto ad ANSI 1982 è che questa
normativa limita l'energia ( il cui calcolo è immediato : se si
ha il valore del SAR va moltiplicato per 3600 secondi ) ; dati sperimentali
ricavati da esperimenti su animali o fantocci forniscono il grafico seguente
:
fig.21 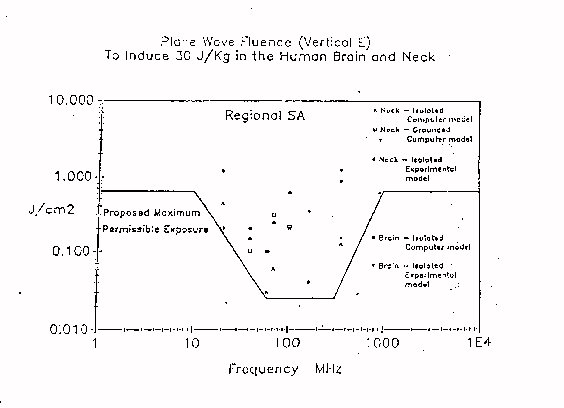
Il discorso fatto è puramente dosimetrico
: considerare il SAR va bene se l’ assorbimento è distribuito
più o meno nell' intervallo dei 6 minuti ; se , invece , tutta l'energia
è concentrata in un intervallo abbastanza stretto bisogna
mettere un limite in termini energetici ( in J/Kg ) ; quindi la nuova normativa
è stata fissata ( anziché a 0.4 W/Kg ) a 30 J/Kg ( così
viene meno il vincolo dei 6 minuti ) .
Non solo si hanno limitazioni in termini di Joule ( energia
ceduta ) , ma anche in termini di campo massimo ; infatti viene data una
potenza massima accettabile espressa in base alla PEAK MPE :
MPE for PEAK POWER
Frequency Range and
Pulsewidth :
0.1 to 300,000 Mhz
100 msec
Maximum Electric Field Strength
:
Peak = 100 kV/m
Maximum Power Density
MPE(CW) x Ave.Time(secs )
Peak MPE = -------------------------------------
(11)
5 x Pulsewidth(secs)
Viene fissato un valore massimo di potenza accettabile
( in continua ) , moltiplicato per il tempo di media di osservazione
( 6 minuti ) si ottiene un' energia , quest' energia viene divisa
per un intervallo di tempo ( con un fattore di sicurezza 5 ) , quindi viene
limitato anche il massimo valore dell' intensità dell'esposizione
: più è piccolo l' intervallo di tempo più questa
quantità sale .
In base a queste quantità si è in grado
di dire qual è il valore massimo e questa rappresenta una novità
della normativa .
L'altra novità, rispetto alla vecchia normativa
, è la distinzione tra ambienti controllati e ambienti non controllati
:
* Nell' AMBIENTE CONTROLLATO la persona che va in quell'ambiente sa
di essere esposta ad un campo più elevato ( vedi tabella ) :
tab.13
Frequency range(MHz) |
E(V/m) |
H(A/m) |
Power_density, s_(mW/cm2) |
Averaging Time (minutes)|E| |H| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frequency range(MHz) |
Maximum Current (mA) |
Maximum Current (mA) |
Maximum Current (mA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In questa tabella vengono dati i valori in termini di campo
elettrico e magnetico nell' intervallo di frequenza che va da 3 Khz a 300
Mhz ; da 300 Mhz in poi si considera un'esposizione in campo lontano (
l'intervallo della media di queste quantità' è sempre di
6 minuti ) .
Per impulsi molto stretti alla frequenza in esame c’è
il rischio di bruciature superficiali
(perché l' mpulso è estremamente elevato ) , quindi la parte
nuova della normativa mira a ridurre la corrente indotta o di contatto
. I valori di densità di potenza sono espressi in mW/cm2 come nella
vecchia normativa .
* Nell' AMBIENTE NON CONTROLLATO :
tab.13
Frequency range(MHz) |
E(V/m) |
H(A/m) |
Power_density, s_(mW/cm2) |
Averaging Time (minutes)|E| |H| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
90,000/f |
|
|
|
|
|
616,000/f1.2 |
Frequency range(MHz) |
Maximum Current (mA) |
Maximum Current (mA) |
Maximum Current (mA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
È presente un fattore di riduzione 5 in termini di potenza ( rispetto al caso di ambiente controllato ) che poi viene scalato nelle altre rappresentazioni ( in termini di campo elettrico o di campo magnetico indotto ) .
Sia nel caso di ambiente controllato che non controllato la tavola è stataa in due parti ( A e B ) che fanno riferimento a differenti condizioni di esposizione secondo le note * , ** , *** riportate in seguito :
* : I valori di esposizione in termini di intensità di campo
elettrico e magnetico sono i valori ottenuti da una media spaziale fatta
su un'area equivala sezione verticale del corpo umano .
** : Quei densità di potenza equivalente all'onda piana , anche
se non appropriati per le condizioni di campo vicino , sono comunemente
usati come paragone con l'MPE alle frequenze più alte .
*** : I limiti dati sopra potrebbero essere non adeguati per proteggere dalle reazioni improvvise causate da emissioni transitorie quando si tocca un oggetto carico .
Sia per quanto riguarda l' ambiente controllato che quello non controllato le esposizioni non sono sempre di 6 minuti , ma possono variare .
Per quanto riguarda le zone in cui l' ESPOSIZIONE è
PARZIALE i valori consentiti sono leggermente più elevati ( resta
comunque la suddivisione tra ambiente controllato e non controllato ) :
tab.15
Frequency range(GHz) |
Peak Valueof Mean Squared Field |
Equivalent Power Density |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si vede dalla tabella che , nel caso di esposizioni controllate resta un fattore 5 ( per frequenze tra 0.3 e 6 Ghz ) , o almeno un fattore 2 ( per frequenze tra 96 e 300 Ghz ) tra ambiente controllato e ambiente non controllato . Il dato che interviene sulla persona viene dato in mW/cm2 .
Tutto ciò che riguarda lo standard americano viene
condensato in un unico schema :
fig.22 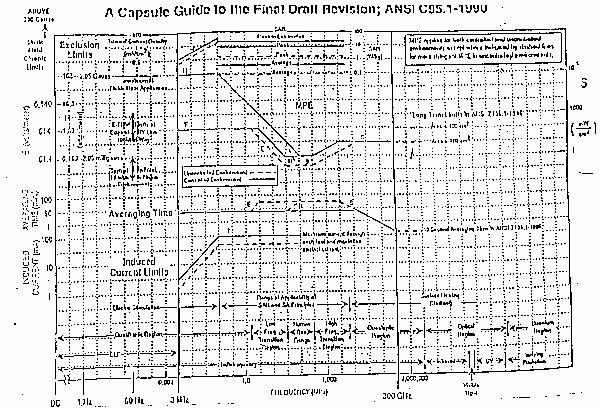
Le tabelle precedenti possono essere rappresentate graficamente :
Nel caso di ambiente controllato AMBIENTE CONTROLLATO :
fig.23 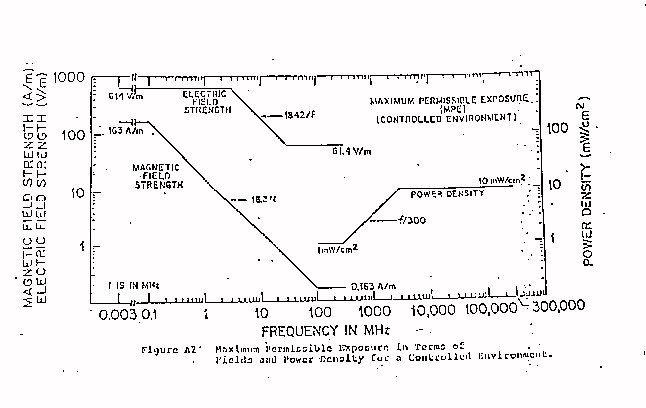
Valgono i discorsi già fatti in termini di
energia : se sono presenti due sorgenti ( una a 200 Mhz e una ad 1 Ghz
) bisogna fare la media delle due.
Il valore minimo , in termini di potenza , si raggiunge
per frequenze che vanno da qualche decina a qualche centinaio di Mhz per
poi risalire e mantenersi costante sui valori più elevati
Nel caso di AMBIENTE NON CONTROLLATO :
fig.24 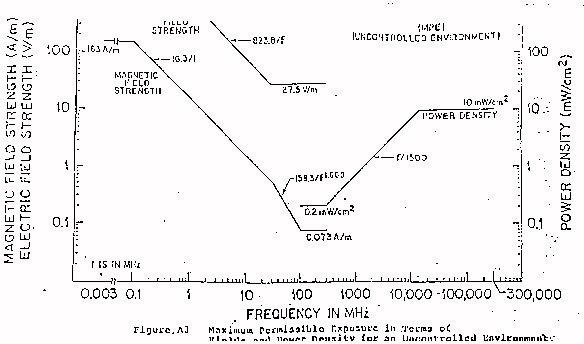
In entrambi i casi viene dato l' MPE ( massimo valore
accettabile ) e quindi nella nuova normativa esiste un limite al campo
massimo .
Facendo il confronto tra le due tabelle si vede che gli
andamenti di intensità di campo elettrico e magnetico e di densità
di potenza sono più o meno gli stessi , ma nel caso di ambiente
non controllato scendono a valori più bassi ; vedi tabella seguente
:
fig.25 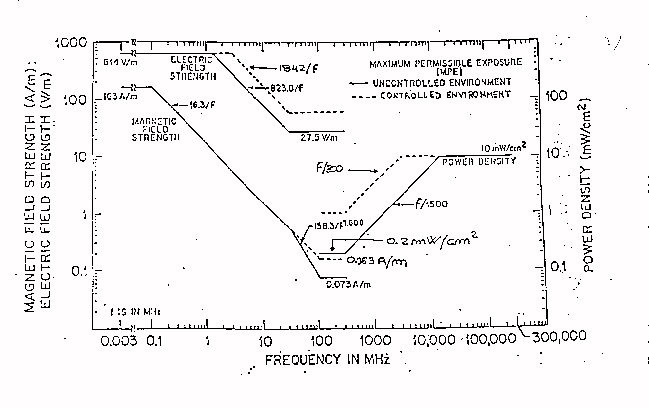
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
6.2.4 Confronto fra i limiti di ANSI 1982 e ANSI 1992
Per il del campo elettrico si ha :
fig.26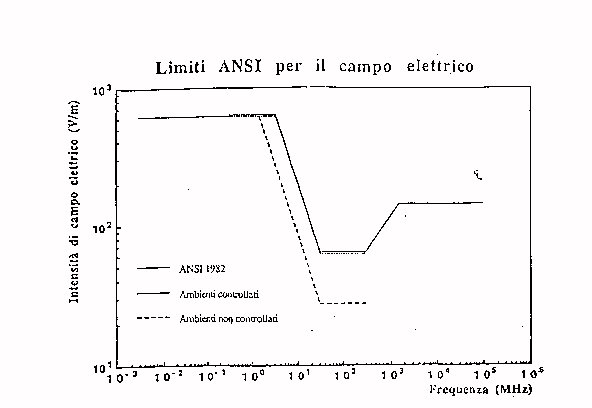
Per il campo magnetico si ha :
fig.27 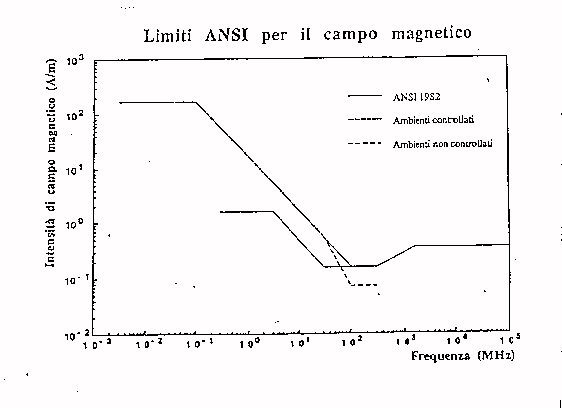
Per la densità di potenza si ha :
fig.28 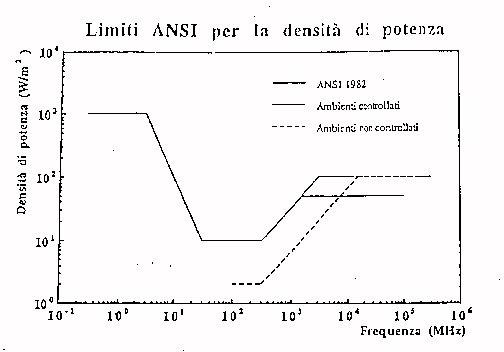
Anche la massima corrente ( sia indotta che di contatto
) attraverso ciascun piede viene analizzato secondo la distinzione tra
ambiente controllato e ambiente non controllato :
nel caso di AMBIENTE CONTROLLATO :
fig.29 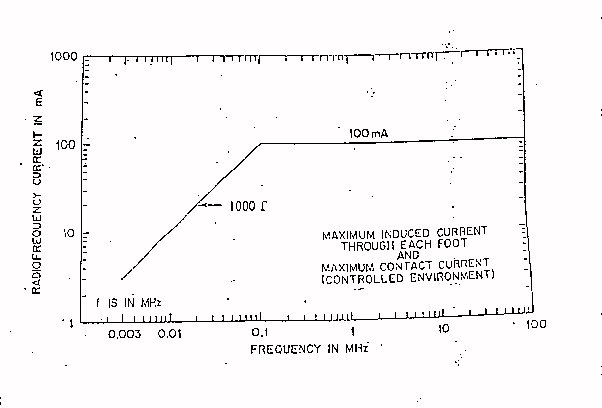
nel caso di AMBIENTE NON CONTROLLATO :
fig.30 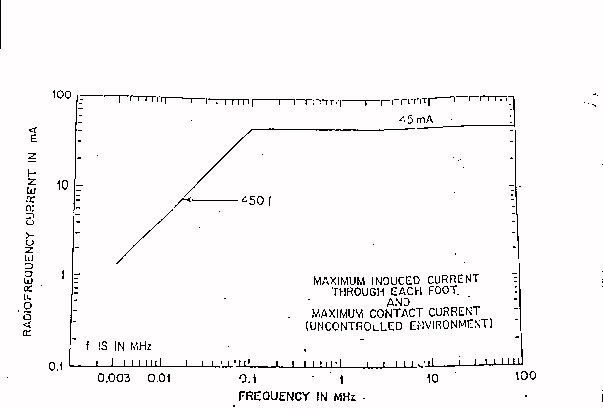
Negli ambienti non controllati c'è una piccola
contraddizione perché , se si va a lavorare vicino ad un trasmettitore
a 88 Mhz che trasmette in FM ( radio privata ) , può succedere
che , se viene messa una persona con i piedi a terra in vicinanza del trasmettitore
( dove il massimo campo permesso è 10 mW/cm2 ) la corrente che scorre
attraverso i piedi è ben maggiore del valore dato dalla normativa
.
Facendo il confronto tra le due tabelle si vede che c'è
un fattore ( di circa ) 2 tra i valori relativi al caso di ambiente controllato
e ambiente non controllato ( vedi grafico seguente ) :
fig.31 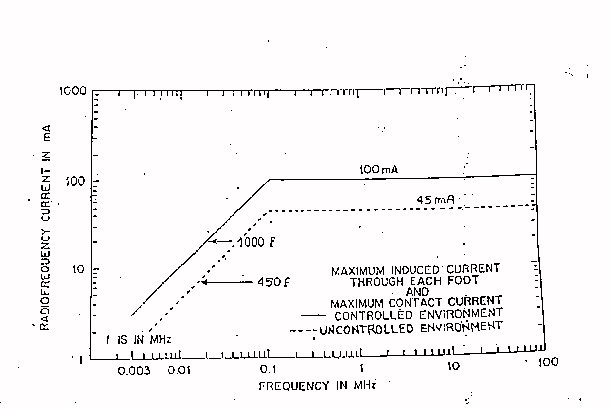
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
6.2.5 IEEE C95.1-1992 ( pag.259/34 e Pag. 259/35 dei lucidi )
Lo standard americano prevede una serie di norme molto discusse per quanto riguarda i telefonini cellulari : da una parte chi compra il telefono cellulare è avvisato di essere sottoposto a campi elettromagnetici ( e quindi si troverebbe in ambiente controllato ) , ma chi va in giro con il cellulare non va in ambienti controllati ; quindi non si riesce a capire che tipo di normativa vada applicata sui telefoni
Negli AMBIENTI CONTROLLATI : per frequenze comprese tra 100 Khz e 6 Ghz l' MPE può essere superato se :
a) si può dimostrare che le condizioni di esposizione possono
produrre valori di SAR inferiori a 0.4 W/Kg come media su tutto il corpo
e inferiori a 8W/Kg come media effettuata per ogni grammo di tessuto ,
fatta eccezione per le mani , i polsi , i piedi e le caviglie dove il SAR
massimo ( spaziale ) non può superare 20 W/Kg , come media fatta
su 10 g di tessuto ( si considera che il volume del tessuto abbia la dimensione
di un cubo ) ,
b)le correnti indotte nel corpo sono conformi con l'MPE di
tab.12 , parte B .
I valori di SAR sono mediati in un
intervallo di 6 minuti . Sopra i 6 Ghz
il rilasciamento dell' MPE è permesso , sotto particolari
condizioni di esposizione .
Per frequenze comprese tra 0.003 e 0.1 Mhz la regola di
esclusione del SAR non si applica . Tuttavia l'MPE in ambienti controllati
può essere superata se si dimostra che la densità di corrente
di picco, mediato su una qualsiasi area di 1 cm2 di tessuto per 1 sec.
, non supera 35 f mA/cm2 dove f è la frequenza espressa in Mhz .
Per apparecchiature a bassa potenza :
A frequenze tra 100 Khz e 450 Mhz l'MPE può essere
superato se la potenza di radiazione si trova al di sotto di 7 W .
Nel range da 0.450 a 1.5 Ghz ( range dei telefonini )
questa quantità viene ridotta ( viene divisa per f ) .
La potenza massima di un GSM è di 2 W e quindi potrebbe
sembrare che i telefoni cellulari siano esentati da questa norma , invece
ci rientrano perché questa norma non si applica se la struttura
radiante è a meno di 2.5 cm dal corpo .
Quindi : quando il telefono cellulare viene allontanato dall'
orecchio si rientra nella norma , quando viene avvicinato si esce
dalla norma .
Per gli ambienti NON CONTROLLATI : a frequenze tra 100 Khz e 6 Ghz , l'MPE può essere superato se :
a) si può dimostrare che le condizioni di esposizione producono un SAR , mediato su tutto il corpo , inferiore a 0.08 W/Kg e un valore di SAR mediato su un grammo di tessuto inferiore a 1.6 W/Kg , fatta eccezione per le mani , i polsi , i piedi e le caviglie dove il picco di SAR ( spaziale ) non superi 4 W/Kg ( si considera che il volume del tessuto abbia la dimensione di un cubo )
b) le correnti indotte nel corpo sono conformi con l' MPE di tab.13 , parte B .
Sopra i 6 Ghz è consentito il rilasciamento dell'
MPE sotto particolari condizioni .
Per frequenze comprese tra 0.003 e 0.1 Mhz la regola di
esclusione del SAR non si applica , tuttavia l'MPE in ambienti non controllati
può essere superata se si dimostra che la densità di corrente
di picco mediata su un qualsiasi area di tessuto di 1 cm2 in un sec.
, non supera 15.7 f mA/cm2 , dove f è la frequenza espressa in Mhz
.
Per apparecchiature a bassa potenza :
Per frequenze tra 100 Khz e 450 Mhz , l'MPE può essere superato
se la potenza radiata è inferiore a 1.4 W .
Per frequenze tra 450 e 1500 Mhz , il valore precedente viene diviso
per f .
Questa esclusione non si applica ad apparecchiature con
struttura radiante che si trova a distanza inferiore a 2.5 cm dal corpo.
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
6.3 ACGIH 1988 ( American Conference of Governmental Industrial Hygienists )
Nel 1988 l' ACGIH stabilì i valori limite
di soglia ( TLVs : Threshold Limit Values ) relativi alle radiazioni a
RF e a MW in un range che va da 10 Khz a 300 Ghz e rappresentanti le condizioni
sotto le quali si suppone che i LAVORATORI possano essere esposti ripetutamente
senza riscontrare effetti dannosi sulla salute . I TLVs sono mostrati nella
seguente tabella :
tab.16
Frequency range |
Power density |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tutte le esposizioni devono essere limitate in accordo
con il principio ALARA dato dalla conoscenza degli effetti sull'uomo ,
in particolare effetti non termici .
Nello standard ACGIH 1988 è permesso che i valori
relativi all'ANSI 1982 possano essere superati controllando che i picchi
non oltrepassino il valore massimo di 8 W/Kg per ogni grammo di tessuto
.
Il valore di 0.4 W/Kg è un valore mediato sul soggetto
; si accetta un'esposizione più elevata ponendo un li mite massimo
al valore di campo che vado a porre all'interno del soggetto .
A frequenze inferiori a 30 Mhz oggetti esposti , come i veicoli , possono accoppiarsi ai campi a RF , a causa di forze di campo vicine ai valori limite di soglia , causando shock e bruciature .
Nello standard ACGIH i campi impulsati , a qualunque frequenza
si trovino , sono limitati ad una intensità massima di campo elettrico
pari a 100 KV/m .
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
6.4 Confronto fra i limiti di ANSI 1982
e ACGIH 1988
Frequency range |
Power density |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frequency range |
Power density |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fig. 32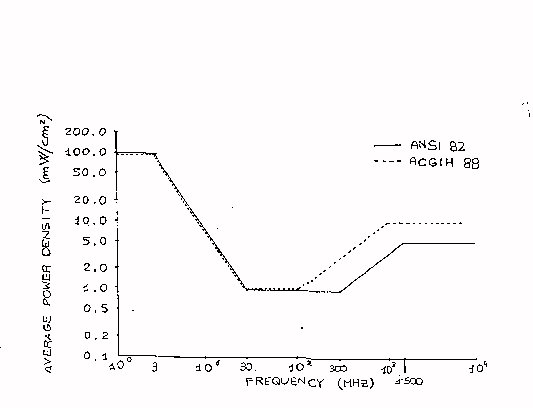
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
6.5 NIOSH 1978 ( National Institute for Occupational Safety and Health )
Nel Maggio 1978 NIOSH ha iniziato il suo lavoro occupandosi
della protezione dei LAVORATORI esposti alle radiazioni a RF e MW.
La tabella che segue mostra i limiti di esposizione proposti
da NIOSH :
tab.17
Frequency range |
Power density |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Analisi di laboratorio , incluse le analisi delle urine , ematocrito
, conta dei globuli bianchi ( WBC ) , conta
differenziale , analisi del siero per le proteine totali , azotemia ( BUN
) , glicemia , albumina , globuline , tetraiodiotironina ( T4 ) ,
elettroliti , trigliceridi , colesterolo , acidi grassi liberi
2) Valutazione delle funzioni cardiovascolari , compreso un
elettrocardiogramma ( ECG ).
3) Valutazione delle funzioni neurologiche , incluso un
elettroencefalogramma ( EEG ) e analisi di eventuali stati di debolezza
, mal di testa , smemoratezza , disattenzione , insonnia , irritabilità'.
4) Analisi della pelle e degli occhi per verificare presenza
di eventuali eritemi o bruciature della pelle , opacità
della cornea e del cristallino , arrossamenti congiuntivali
e corneali.
Un primo esame può essere fatto a tutti i nuovi
impiegati , ponendo particolare attenzione a possibili esposizioni a radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti .
A discrezione può essere fatto un ulteriore controllo
dopo 1-2 mesi dopo l'esposizione .
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
6. 6 Confronto fra i limiti di NIOSH 1978 e ANSI 1982
Come le norme ANSI , anche queste normative dipendono dalla
frequenza ; se confrontiamo le due tabelle i valori trovati differiscono
di poco :
Frequency range |
Power density |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Frequency range |
Power density |
Electric field strength |
Magnetic field strength |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I range di frequenza sono leggermente diversi , ma sono
comunque divisi in cinque zone .
NIOSH è un ente più protezionistico rispetto
all' ANSI , infatti : per quanto riguarda la parte di basse frequenze i
valori della normativa NIOSH sono più bassi , mentre nella parte
di alta frequenza i valori sono uguali ( sulle tabelle i valori risultano
diversi perché i range di frequenza sono diversi ) .
La normativa della NIOSH parte , anziché da 100
mW/cm2 , da 25 mW/cm2 , scende un po' in anticipo , resta costante
per un lungo periodo e poi risale un po' più in alto .
fig.33 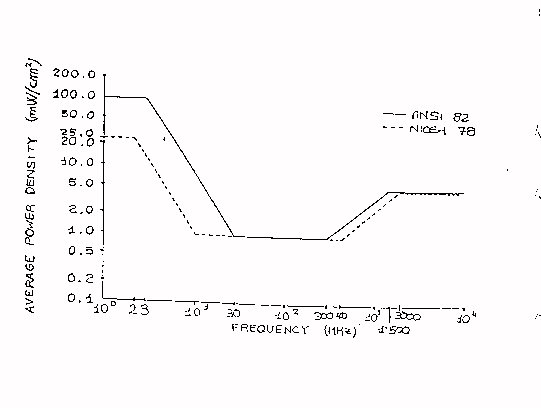
Vai all'inizio del capitolo
Vai all'inizio del paragrafo
Torna all'indice